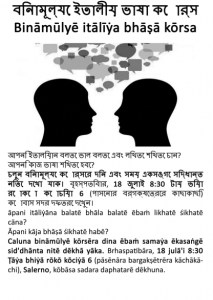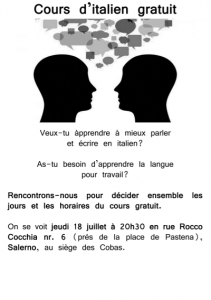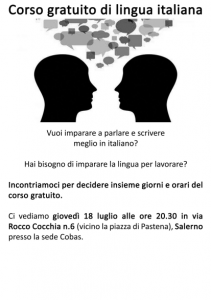di Sherronda J. Brown
QUELLO CHE STA SUCCEDENDO A MARSHAE JONES È L’ENNESIMO PROMEMORIA CHE IL MOVIMENTO PRO-CHOICE DEVE SPOSTARSI VERSO LA GIUSTIZIA RIPRODUTTIVA.
Marshae Jones è stata arrestata mercoledì a Birmingham, in Alabama, dopo essere stata incriminata da una giuria di Jefferson County per omicidio colposo per la morte di un feto. Jones era incinta di cinque mesi quando una lite fisica le ha provocato un colpo allo stomaco e ha causato la perdita della gravidanza l’anno scorso. Colei che ha sparato, Ebony Jemison, ha visto cadere tutte le accuse contro di lei nel momento in cui gli investigatori hanno insistito sul fatto che Jones fosse colpevole perché avrebbe provocato la lite.
La co-fondatrice e direttrice esecutiva di UltraViolet, Shaunna Thomas, ha affermato in una dichiarazione ufficiale: “Questa è la collisione tossica tra razzismo, sessismo e la violenza quotidiana vissute dalle donne di colore e il terrificante punto finale delle pericolose leggi anti-choice che si diffondono in tutto il paese, incluso l’Alabama, che svaluta, disumanizza e criminalizza le donne. Invece di trattare Marshae Jones con compassione dopo essere stata colpita e aver perso la gravidanza, l’Alabama ha deciso di favorire il trauma e l’ingiustizia che ha già provato incolpando lei, non la persona che le ha sparato, con un crimine … Questo fa parte di un più ampio modello di come il nostro sistema di giustizia penale consente e promuove la violenza e gli abusi contro le donne nere, ed è inaccettabile “.
Il Fondo Yellowhammer, un’organizzazione che “fornisce finanziamenti a chiunque cerchi assistenza in una delle tre cliniche per l’aborto dell’Alabama e che aiuterà con altri problemi che impediscono l’accesso”, si sta attualmente organizzando per raccogliere denaro per la cauzione e per assistere Jones legalmente.
Il caso contro Marshae Jones non è, sfortunatamente, anomalo o senza precedenti. Nel 2007 un gran giurì della contea di Lowndes ha incriminato Rennie Gibbs, 16 anni, per “omicidio privo di cuore”, che la legge del Mississippi definisce un atto “eminentemente pericoloso per gli altri … indipendentemente dalla vita umana”, dopo aver prematuramente partorito un bambino nato morto. È stata accusata di essere colpevole della morte fetale perché aveva usato la cocaina durante la gravidanza. Questa donna nera, un’adolescente al momento di questo trauma, rischiava di essere la prima persona nella storia del Mississippi a essere incriminata per la perdita della propria gravidanza, ma per fortuna le sue accuse sono state respinte nel 2014.
Più recentemente, Latice Fisher, anche lei donna del Black Mississippi, è stata incriminata per un reato di secondo grado nel 2018 e rischia da 20 a 40 anni di carcere. È entrata in travaglio e ha partorito a casa, ma il suo bambino è deceduto quando è arrivata all’ospedale. Laurie Bertram Roberts, co-fondatrice del Mississippi Reproductive Freedom Fund (MRFF), ha detto a Rewire l’anno scorso: “Cosa sta succedendo alla signora Fisher e alla sua famiglia è l’ultimo caso di una serie in cui donne di colore vedono le loro gravidanze e in particolare la perdita di gravidanza criminalizzata. È una tendenza inquietante. Dato ciò che è stato reso pubblico, qui non vedo nessun crimine, solo una perdita”.
Purvi Patel è stata condannata a 20 anni nel 2015 dopo che un tentativo di abortire auto-indotto con farmaci si è concluso in un aborto, diventando la prima persona nella storia degli Stati Uniti ad essere accusata, rinchiusa e condannata con un’accusa di feticidio. La sua condanna più grave è stata ribaltata nel 2016, riducendo la condanna per negligenza verso minore da un crimine di classe A a una classe D. Affrontando il caso Patel, la direttrice della Rete Nazionale di fondi per l’aborto (NNAF), Yamani Hernandez ha commentato: “La gente di colore sta sopportando il peso delle leggi non scientifiche e il malcontento morale fuori luogo contro l’aborto, che si confonde nel territorio dell’aborto spontaneo, mettendo a rischio di accusa e incarcerazione le persone incinte. E’ qualcosa da fermare.”
Sebbene sappiamo che la gravidanza non è un’esperienza limitata alle donne cis, la comprensione sociale delle gravidanze normate è di genere e generalmente osservata come un’estensione dell’essere donna, per cui le leggi relative alla gravidanza e la criminalizzazione dell’aborto e dell’aborto spontaneo sono anche genderizzate e sotto l’influenza della misoginia. La considerazione degli uomini cis per la salute e i processi riproduttivi delle donne cis è misteriosa, spaventosa e grossolana, ma è sicuramente sentita la necessità che debba essere controllata dagli uomini a causa della percepita irrazionalità e irresponsabilità delle donne, e contribuisce al modo in cui queste cose vengono considerate nel sistema legale. La loro ignoranza e le incomprensioni fondamentali su come funzionino i “corpi delle donne” causa una rottura nella più ampia comprensione sociale di queste cose, che consente al sistema legale di creare un tipo di colpevolezza contraddittorio sulle donne incinte, una colpevolezza che abita l’immaginario sociale.
Le persone incinte sono allo stesso tempo viste come completamente responsabili e individualmente delle loro gravidanze e colpevoli per i loro aborti spontanei, indipendentemente dal modo in cui si verificano, ma anche non autorizzate a gestire autonomamente il proprio corpo perché non sono considerate abbastanza responsabili da prendere decisioni sulla propria salute riproduttiva (o vita sessuale). Ciò significa che le persone gravide sono gravate dalla responsabilità di provare che un dato aborto spontaneo non sia colpa loro, ma allo stesso tempo spesso non viene loro concesso il diritto di porre fine a una gravidanza alle loro condizioni, anche se la gravidanza è dannosa per il feto, loro stessx o entrambx.
In “L’evento che non è stato niente: l’aborto spontaneo come evento criminale” dal Journal of Social Philosphy, Alison Reiheld mette in evidenza come l’aborto spontaneo si connetta con l’aborto e l’intento dello stato di avere il controllo sulle persone incinte attraverso il linguaggio e la percezione. Scrive: “Un termine clinico per l’aborto spontaneo (miscarriage in inglese), “aborto spontaneo” rivela alcune di queste liminalità. Descrittori clinici specifici per tipi di aborto includono “aborto completo”, “aborto incompleto”, “aborto inevitabile”, “aborto infetto (settico)” e “aborto mancato” … Colloquialmente, l’aborto spontaneo può essere descritto come una “gravidanza persa” o una “gravidanza fallita”. Questo è un uso solo leggermente migliore dell’uso clinico del termine “aborto”, poiché anche se comporta anche un grado di agency da parte della donna incinta, qui è più una questione di omissione che di esecuzione. Una gravidanza persa deve essere stata persa da qualcunx; qualcunx deve aver fallito per essere una gravidanza fallita”.
Reiheld continua a enumerare come la mancanza di comprensione per quello che è realmente un aborto spontaneo e il desiderio di punire le persone incinte (inteso come donne) crea il tipo di leggi che sono state approvate quest’anno e risultati come quello di Marshae Jones:
“1. Leggi che cercano di controllare l’aborto richiedendo alle donne di dimostrare che la perdita della gravidanza è dovuta a un aborto spontaneo piuttosto che all’aborto o all’infanticidio indotto.
2. Leggi che consentono agli operatori sanitari di rinunciare al trattamento dell’aborto spontaneo perché si utilizzano tecniche simili all’aborto.
3. Leggi il cui effetto è quello di ritenere le donne penalmente responsabili di aborti spontanei quando le loro azioni hanno avuto un ruolo causale plausibile nella perdita della gravidanza.
Sono quindi leggi che iscrivono l’aborto spontaneo nel dibattito sull’aborto (1 e 2) e leggi che iscrivono l’aborto spontaneo nei dibattiti sul controllo della gravidanza (3).”
L’Alabama, dove risiede Jones, era tra il numero di stati degli Stati Uniti che hanno passato alcuni dei più severi divieti della nazione all’inizio di quest’anno, con una legge che classifica l’aborto come un crimine di classe A e potrebbe portare coloro che praticano aborti in carcere fino a 99 anni. Il divieto di aborto della Georgia include anche la punizione per coloro che cercano aborti in aggiunta ai medici che forniscono il servizio. La legge HB 481 dello stato stabilisce che un feto debba essere trattato come persona completa con “pieno riconoscimento legale” dal momento del concepimento, e la terminologia di questa legge rende facile per la Georgia perseguire le persone che abortiscono se si ritiene che siano in qualche modo responsabili della perdita della gravidanza, che questa convinzione sia arbitraria o meno. Essenzialmente, ogni persona una volta incinta poteva essere ritenuta legalmente responsabile per non aver portato a termine una gravidanza. Questo livello di controllo riproduttivo è terrorismo e controllo del corpo come niente altro.
Le persone BIPOC sono criminalizzate in modo sproporzionato e sono oggetto di azioni penali per i risultati devastanti delle loro gravidanze. Lo sforzo conservatore di conferire un “essere individuo” ai feti è sempre stato prodotto della misoginia e del controllo delle persone incinte – che sono ostentatamente intese come donne cis – ma è stato utile anche per promuovere la portata del sistema carcerario, che influisce sulla vita delle persone povere e BIPOC più che per chiunque altrx.
Se le rigide leggi sull’aborto come quelle che abbiamo visto quest’anno continueranno, specialmente quelle con terminologia che consente il perseguimento in caso di aborto spontaneo, si creeranno condizioni più pericolose per le persone BIPOC gravide, mettendo loro a rischio ancora maggiore di incarcerazione.
Quello che sta succedendo a Marshae Jones, e altrx come lei, è un altro promemoria del fatto che i movimenti per i diritti riproduttivi devono andare oltre la retorica “pro-choice” e lavorare verso la giustizia riproduttiva, mettendo al centro di questo lavoro soprattutto le persone BIPOC.
È un promemoria che le questioni relative al controllo riproduttivo non possono essere separate dal sistema carcerario, che le politiche anti-abortive e simili mirano agli individui più emarginatx e che l’abolizione carceraria è qualcosa che dobbiamo innalzare nella nostra lotta per la libertà riproduttiva e l’autonomia dei corpi.
Fonte: https://wearyourvoicemag.com/health/reproductive-justice/marsha-jones-reproductive-justice-abortion-laws