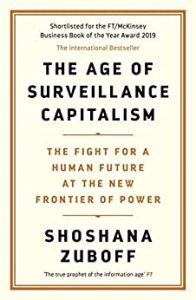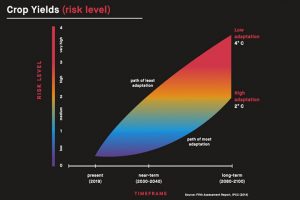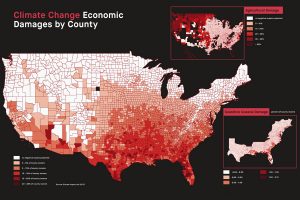Fonte: https://libcom.org/blog/labour-defeat-thoughts-democratic-socialism-21122019
di AngryWorkersWorld’s blog
Il “socialismo democratico” è attualmente il principale modello alternativo nel progetto di una trasformazione del capitalismo e quindi, in quanto tale, dobbiamo prenderlo sul serio, nonostante il nostro profondo disaccordo con esso. Con socialismo democratico intendiamo l’idea che usando le due gambe del movimento operaio organizzato – i sindacati e un partito socialista al governo – possiamo camminare passo dopo passo verso il socialismo. Il socialismo è definito come una società dominata dalla proprietà nazionalizzata o cooperativa dei mezzi di produzione e della rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici quando si tratta della gestione di queste unità economiche. La strategia generale del socialismo democratico può essere sintetizzata brevemente.
L’idea è quella di fare una campagna per la vittoria elettorale di un partito socialista basato su un programma economico di parziale ri-nazionalizzazione di un numero limitato di settori chiave e sulla creazione di un settore più ampio di “economia solidale” formato da società cooperative o municipali che possano garantire una partecipazione più decentralizzata di lavoratori e lavoratrici. Insieme alle attività elettoralistiche, i socialisti democratici incoraggiano il sostegno della classe lavoratrice o delle organizzazioni dei “movimenti sociali” al di fuori del parlamento, al fine di disporre di una base di potere economico per esercitare pressione sia sul capitale che sul governo. Una volta che il partito è al potere, la strategia deve creare una dinamica tra a) cambiamenti istituzionali strutturali decretati dal governo che crei più spazio per la partecipazione delle organizzazioni della classe operaia (le cosiddette riforme non riformiste) e b) pressioni dal basso per difendere ed estendere questi spazi. Un esempio potrebbe essere quello di attuare riforme del settore bancario, che limitino la portata della speculazione finanziaria e dell’elusione fiscale e allo stesso tempo offrano un trattamento preferenziale alle “imprese di proprietà comune” quando si tratta di crediti commerciali. Mentre ciò accade a livello governativo, i sindacati delle aziende che potrebbero tentare di minare la riforma minacciando di disinvestire dovranno aumentare la pressione sulla gestione. I miglioramenti materiali della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e il rafforzamento dei sindacati dovrebbero creare una maggiore unificazione all’interno della classe lavoratrice – una sorta di trampolino verso il socialismo.
Ci sono due cuori pulsanti in questo progetto. Vediamo moltx compagnx, stufx dell’isolamento sociale della cosiddetta “politica rivoluzionaria”, attrattx dai dibattiti pratici e strategici del progetto socialista democratico, che possono essere intellettualmente stimolanti. Questx compagnx possono provenire da organizzazioni anarchiche classiche o comunque “rivoluzionarie” o possono essere statx politicizzatx durante [la militanza] nei “movimenti sociali” orizzontali ma inefficaci e spesso autoreferenziali dell’era anti-globalizzazione o di Occupy. Comprendiamo la voglia di questx compagnx di “fare la differenza” e di pensare a passi a breve, medio e lungo termine verso il cambiamento sociale. Possiamo vedere molte persone della classe operaia che percepiscono i limiti dell’attività sindacale e che sperano che il Labour al governo possa trasformare i sindacati in potenti organizzazioni dei lavoratori. Vogliamo parlare al cuore di questx compagnx. Altra cosa è la solita palude fatta di politicanti all’interno di queste organizzazioni, dai DSA a Podemos al Labour di Corbyn, dove ci sono i soliti scontri e giochi di potere.
La direzione del progetto socialista democratico nel Regno Unito non è determinata principalmente dalle sue prospettive politiche, ma dalla sua composizione di classe. La nuova sinistra laburista è composta da tre forze principali: un settore di professionisti ambiziosi (anche precari) che sentono che secondo il loro stato di istruzione dovrebbero avere più voce in capitolo nella società. Vogliono anche una buona vita per “la classe lavoratrice”, ma il loro approccio è tecnocratico: persone istruite ed esperti progressisti dovrebbero decidere come vanno le cose, non i banchieri e l’élite parassitaria. Formano un’alleanza con la seconda forza principale, la burocrazia sindacale. L’apparato sindacale consente ai nuovi professionisti di parlare in nome dei lavoratori e delle lavoratrici e i capi sindacali possono estendere il loro potere nella classe politica. Il terzo elemento sono le parti più emarginate della classe lavoratrice che hanno dovuto subire anni di tagli e sanzioni. Il Labour guidato da Corbyn ha dato loro speranza, ma la macchina del partito finirà per strumentalizzare il loro status di vittime.
Potremmo scrivere un lungo elenco di punti di disillusione per il Corbinismo, che hanno avuto luogo anche prima del disastro elettorale. Il secondo leader dell’ala “di sinistra dura” del partito, John McDonnell, si sentì obbligato a sdoganare pubblicamente il criminale di guerra Tony Blair. Le persone che hanno votato con Blair per invadere l’Iraq sono presentate e ospitate come “candidati di sinistra”, come il deputato David Lammy. Gli attivisti alla conferenza del partito del 2017 hanno appreso che Momentum [l’organizzazione laburista che racchiude la sinistra del partito ascesa alla guida del Labour con Jeremy Corbyn NdR] poteva essere usato come braccio disciplinare, impedendo che i delegati votassero su questioni controverse, come il referendum sulla Brexit. Le attività nelle sezioni locali di partito sono in gran parte dominate da giochi di potere meschini e da formalità noiose.
Durante l’inverno 2019/20 si è scoperto che l’unica cosa che il Corbinismo è stato in grado di ri-nazionalizzare è la sinistra del partito. Mentre assistevamo a una delle più grandi ondate di proteste della classe lavoratrice – dall’Ecuador al Cile, dal Sudan all’Iran – la sinistra nel Regno Unito era completamente concentrata su tutto ciò che Corbyn o Johnson stavano dicendo in TV. La ristretta visione nazionalista sarebbe peggiorata se i laburisti fossero entrati nel governo: un socialista democratico avrebbe sostenuto mobilitazioni indisciplinate della classe lavoratrice, come i gilet gialli o le proteste in Iran, sotto un nuovo e fragile governo laburista? Possiamo provare ad adornare il “Corbinismo” con ogni tipo di armamentario dall’aspetto radicale e pensare nuovi meme, dal “corbinismo acido” al “vero comunismo di lusso” – ma alla fine abbiamo solo un partito che ci promette un aumento minimo del salario, banda larga gratuita e leggermente meno austerità. Ma il nostro obiettivo qui non è discutere di visioni utopiche, ma sottolineare le carenze interne di questa strategia politica.
1) Quella attuale non è una fase storica favorevole alla socialdemocrazia
Storicamente, la socialdemocrazia si è sviluppata durante le fasi di ripresa economica, basata su una capacità di produzione industriale nazionale relativamente forte. Ciò che affrontiamo ora è una crisi economica e un sistema di produzione internazionalizzato. Ciò limita sia l’ambito delle concessioni materiali sia le politiche economiche nazionali. In secondo luogo, la socialdemocrazia divenne principalmente egemonica nelle situazioni post-rivoluzionarie. La socialdemocrazia si basava su grandi organizzazioni all’interno della classe lavoratrice e su una classe dominante che consentiva la rappresentanza politica dei lavoratori e delle lavoratrici al fine di evitare tensioni rivoluzionarie. I comunisti di sinistra non si stancano mai di ripetere che l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale non è stata il risultato del riformismo del partito laburista, ma della contro-insurrezione dei Tory nella guerra fredda – per evitare il malcontento sociale su larga scala dopo la guerra. Ancora una volta, questa non è la situazione in cui ci troviamo oggi. Il punto principale che dobbiamo sottolineare è: affrontiamo condizioni di lotta più dure rispetto a quelle cui il socialismo democratico ci prepara. Non possiamo ignorare gli scontri quotidiani con i padroni e i loro violenti lacchè. Il socialismo democratico tende a enfatizzare eccessivamente l’autonomia della politica del governo. Nel Regno Unito la sinistra laburista ritrae il governo Thatcher e le sue “politiche malvagie” come la fonte del neoliberismo malvagio, mentre fu la crisi globale a metà degli anni ’70 che costrinse tutti i governi ad attaccare la classe lavoratrice. Non puoi votare per uscire da una cosa del genere.
2) Il socialismo democratico attuale ignora il carattere capitalista dello Stato
Le strategie socialiste democratiche si basano sul presupposto che lo stato sia al di sopra del “capitalismo” e possa quindi intervenire in esso come una forma politicamente neutra. Storicamente lo stato è emerso come il braccio violento per imporre e garantire relazioni di classe, ad esempio attraverso la definizione della proprietà privata, le leggi sui vagabondi e l’espansione militare dei mercati. Lo stato appare come una forza neutrale che è lì solo per occuparsi della legge e dell’ordine e della più ampia organizzazione della società. Ma la legge e l’ordine significano principalmente che le relazioni di proprietà che sono la base materiale per lo sfruttamento della classe lavoratrice vengono mantenute. Rendendoci cittadini, lo stato ci disarma come forza collettiva di classe. La politica statale separa la sfera della produzione sociale dalla sfera del processo decisionale sociale – dovremmo produrre il mondo, ma a parte dare un voto ogni quattro anni non abbiamo voce in capitolo su come è gestito il mondo. Materialmente l’apparato statale dipende dallo sfruttamento continuo ottenuto sia attraverso la tassazione che con il lavoro salariato.
3) Il socialismo democratico attuale fraintende il rapporto tra mercato e capitalismo
I socialisti democratici pensano che il passaggio dalla proprietà privata a quella pubblica (statale) sarà l’antidoto al capitalismo. Non vedono quindi alcuna contraddizione tra un “grande stato” e il socialismo, nonostante il fatto che l’intervento dello stato – indipendentemente da dove si trovi nello spettro politico – abbia sempre svolto il ruolo fondamentale nell’espansione, applicazione e difesa del mercato. Lo stesso processo di industrializzazione richiedeva la proprietà statale e la pianificazione economica centrale, ultimo ma non meno importante elemento per far rispettare l’ordine contro la classe lavoratrice industriale emergente. Durante questa fase non importava se la sinistra o la destra fossero al governo – la situazione sociale richiedeva una pianificazione statale su larga scala e non era una scelta politica. Inoltre, l’idea che le cooperative e la proprietà nazionale (statale) vadano di pari passo non è verificata dalla storia: il grande declino delle cooperative nel Regno Unito non è avvenuto sotto Thatcher, ma durante l’ascesa della pianificazione economica nazionale e della concentrazione nella produzione del settore durante un governo laburista degli anni ’60. La competizione tra aziende – la forma del mercato – o la formazione di monopoli è solo un’apparenza superficiale delle relazioni di classe sottostanti. Quindi non basterebbe solo “distruggere i monopoli”. È necessario un cambiamento ancora più fondamentale. Possiamo vederlo quando le relazioni di classe sono in crisi, quando i lavoratori e le lavoratrici organizzano scioperi di massa e scendono in strada. Lo stato, non importa se sia di destra o di sinistra, non ha problemi a sospendere il “libero mercato” in queste situazioni per reprimere e mantenere la società di classe. Ad esempio, dopo lo shock petrolifero degli anni ’70, non era in contraddizione che il governo di Indira Gandhi nazionalizzasse il settore minerario e bancario al fine di prevenire il collasso economico, nominasse il “socialismo” nella costituzione indiana, ottenesse il sostegno del Partito comunista e lanciasse contemporaneamente l’attacco più brutale contro gli scioperi dei ferrovieri e altri ribelli della classe operaia durante lo stato di emergenza.
4) Il socialismo democratico in pratica esorcizza la debolezza strutturale della classe lavoratrice concentrandosi sui professionisti
Gli attuali sostenitori del socialismo democratico sanno che la lotta di classe è a un basso livello, ma invece di concentrarsi sulla costruzione di nuclei organizzati all’interno della classe, si concentrano in gran parte sul reclutamento di professionisti e “attivisti”. Mentre precedenti sconvolgimenti rivoluzionari come il 1968 hanno messo in dubbio il ruolo dell'”intellettuale esperto”, l’attuale generazione lo celebra. Questo è molto ovvio per partiti come Podemos o Syriza, ma vale anche per la ripresa del Labour: la maggior parte dei nuovi membri del partito ha un’istruzione superiore e vive in aree metropolitane. Materialmente la nuova intellighenzia di sinistra si riproduce come il “l’individuo neoliberista” che finge di criticare: quasi nessuno di loro è un “intellettuale organico” forgiato nell’esistenza e nella lotta della classe operaia, la maggior parte sopravvive creando un’immagine social e accademica la cui opinione è valutata sul mercato. Sia che tu legga i “Modelli alternativi di proprietà” dai consiglieri del partito laburista, il “luxury communism” di Bastani o “Inventing the Future” di Srnicek, il soggetto principale è sempre la figura dell’attivista ben istruito e connesso in rete. Sfortunatamente questo costringe i nostri compagni socialisti democratici intellettuali a inseguire la propria stessa retroguardia. C’è un grande spazio vuoto quando si tratta della domanda su come le loro idee ben intenzionate verranno applicate e implementate. Chi imporrà la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici se sono viste come persone che sono in grado di impegnarsi in un discorso politico solo durante le elezioni? L’assenza di una strategia radicata nella classe lavoratrice porta quindi alla creazione di un’icona banale e kitsch del “popolo” – una massa di vittime oneste che hanno bisogno di appartenenza culturale e leadership politica.
5) La comprensione del socialismo democratico della “partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici” è formale e dunque imperfetta
Critichiamo i pensatori socialisti per aver visto la pianificazione statale essenzialmente opposta al capitalismo, sebbene di fronte alla storia la maggior parte di loro si affretterebbe ad aggiungere che la nazionalizzazione e la pianificazione devono andare di pari passo con la “democratizzazione dell’economia”. Il problema è che la loro comprensione della “partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici” è in gran parte formale, ad es. proposta sotto forma di quote dei lavoratori e delle lavoratrici nelle imprese, delegati sindacali nei consigli di amministrazione o diritto di voto quando si tratta di decisioni di gestione. Il suddetto background di classe di molti dei nuovi intellettuali socialisti contribuisce anche alla comprensione limitata – o alla reale traiettoria – di ciò che il controllo dei lavoratori e lavoratrici richiederebbe. La loro comprensione della classe è ampiamente economicistica – definita dal fatto che tutti i lavoratori dipendono dai salari. Questa comprensione della classe non si concentra sulla forma effettiva del processo di produzione e sulla sua divisione gerarchica del lavoro (lavoratori e lavoratrici intellettuali e manuali, lavoro produttivo e riproduttivo ecc.). Nelle loro politiche, la loro comprensione della “proprietà” dei mezzi di produzione e della “partecipazione democratica” dei lavoratori è formale. Solo perché i lavoratori e le lavoratrici o i sindacati detengono il 50% o il 100% delle azioni non significa molto. Se i lavoratori e le lavoratrici sono ancora costrette a sgobbare tutto il giorno, eseguendo solo una quantità limitata di compiti, questo non permetterà loro di comprendere, e quindi dire, come un’azienda o un settore sono effettivamente gestiti. Puoi dare loro un voto in un consiglio di amministrazione dell’azienda, ma saranno coloro che avranno una visione più ampia e più tempo – a causa del loro status professionale di intellettuali (ingegneri, scienziati ecc.) – che prenderanno le decisioni. Il “voto” sarà ridotto a un processo feticistico per confermare il monopolio delle conoscenze degli esperti. Come abbiamo visto nella storia, i lavoratori e le lavoratrici sopravvivono alle peggiori sconfitte inflitte dal nemico di classe. Ma i traumi più profondi e duraturi vengono inflitti quando l’oppressione e lo sfruttamento vengono attuati a loro nome – lo “stato operaio” del regime stalinista non apparteneva formalmente anche ai lavoratori e alle lavoratrici? Un semplice cambiamento nel governo o un passaggio dalla proprietà privata a quella statale non toccherebbe il nucleo di ciò che definisce la “classe lavoratrice”, il suo potere o la mancanza di potere.
6) I sindacati e il partito dei lavoratori non sono la classe operaia
La prospettiva socialista democratica si basa sull’idea di una trasmissione tra la classe lavoratrice e lo stato attraverso l’interazione delle due principali “organizzazioni dei lavoratori e delle lavoratrici” – il partito parlamentare e i sindacati. Questa prospettiva si basa su una visione idealistica o preistorica dei sindacati come “rappresentazione democratica” della classe. Molti esempi storici (Labour-TUC nel Regno Unito nel 1926 o negli anni ’70, CC.OO in Spagna dopo Franco, Solidarnosc in Polonia dopo il 1981, PT-CUT in Brasile di recente ecc.) dimostrano che durante il momento più intenso delle ondate di lotta, il collegamento sindacale-governativo diventa l’ostacolo più pesante per l’iniziativa della classe lavoratrice. Durante gli ultimi anni in cui siamo stati rappresentanti sindacali, abbiamo avuto la possibilità di conoscere un bel po’ dei meccanismi interni di due importanti sindacati, entrambi fedeli al partito laburista. L’idea del socialismo democratico che queste organizzazioni siano la forza principale nel “tenere sotto pressione il governo e i suoi nemici” è totalmente illusoria. Il più delle volte possiamo vedere come il partito e la leadership sindacale strumentalizzino le lotte dei lavoratori e lavoratrici per i propri fini, ad es. i recenti “scioperi” simbolici al McDonald’s di Londra sono stati chiamati dalla dirigenza sindacale in un momento in cui si adattavano al circo della campagna laburista, ma in realtà hanno minato il lavoro organizzativo del sindacato. Molte delle riforme proposte che il Labour voleva introdurre, ad es. la contrattazione collettiva settoriale e i contratti, faciliterebbero la pianificazione economica per i più grandi capitalisti e rafforzerebbero la presa della leadership del sindacato centrale piuttosto che aumentare il potere indipendente dei lavoratori e delle lavoratrici. I contratti regionali e settoriali in Germania sono il miglior esempio.
7) Concentrarsi sulla “politica di palazzo” è uno spreco di energie
La leadership del socialismo democratico tende a cercare di aggirare i complessi problemi quotidiani delle relazioni di potere tra lavoro salariato e capitale e si concentra invece sull’avanzamento elettorale. Ma le questioni elettorali tendono a diventare un andare avanti e indietro. La politica governativa del socialismo del XXI secolo in America Latina (Chavez, Morales, Lula ecc.) e le sue debolezze strutturali hanno creato una diffusa disillusione. La sottomissione del governo Syriza in Grecia al sistema e ai suoi rappresentanti ha chiuso, piuttosto che aprire spazi per il movimento di classe contro l’austerità. Le lotte di potere interne a Podemos o a Momentum hanno creato cinismo e stanchezza. Adottando una strategia di voto per il “male minore” e chiedendo alle persone di votare per Macron per evitare Le Pen, la sinistra ha minato la propria posizione nella ribellione antigovernativa dei gilet gialli. Il clamore mediatico del corbinismo, l’impegno con le tattiche elettorali ecc. deviano l’attenzione dalle lotte quotidiane per l’autodifesa della classe lavoratrice. C’è anche un fraintendimento del parlamentarismo: solo perché un partito politico è composto da lavoratori e lavoratrici, ciò non rende la politica del partito e il parlamento una forma di politica della classe lavoratrice. Il parlamentarismo è l’esatto contrario della politica della classe lavoratrice, poiché si basa sulla cittadinanza individuale, non su relazioni collettive e pratiche. Ciò vale sia per il parlamentarismo nazionale sia per il “parlamentarismo light” sotto forma di “municipalismo radicale” (campagna per candidati indipendenti alle elezioni locali) che alcuni attivisti propongono. Il miglior esempio per descrivere i limiti della politica elettorale locale può essere trovato negli Stati Uniti. L’elezione di militanti del movimento di liberazione nera dopo il suo declino alla fine degli anni ’70 ha significato che in città come Chicago e Baltimora, i sindaci neri hanno dovuto applicare misure di austerità e di polizia contro le persone povere negli anni ’80, che hanno ulteriormente indebolito e diviso il movimento mentre hanno stabilizzato il sistema: chi meglio per far applicare tagli contro le persone nere povere delle città, che un sindaco nero? Mentre la storia ci fornisce ampi esempi, nel presente appaiono anche delle crepe. Se osserviamo Barcelona En Comu, la piattaforma dei cittadini che ha vinto le elezioni locali a Barcellona ed eletto la nuova sindaca, Colau, possiamo vedere vari momenti di tensione tra la classe lavoratrice locale e il nuovo governo locale “amico dei cittadini”, ad es. quando il governo locale ha agito contro i lavoratori e lavoratrici dell’aeroporto e della metropolitana in sciopero nel 2017. I/le compagnx spagnolx hanno anche notato che la “ridistribuzione” degli stipendi dei politici locali in piattaforme come Barcelona En Comu non ha favorito una maggiore equità interna ma ha creato un rafforzamento del ceto politico di movimento, un nuovo livello di attivisti professionisti con tutte le contraddizioni della professionalizzazione. Un risultato di queste tensioni con la classe lavoratrice locale è che Barcelona En Comu cerca di incanalare un po ‘del malcontento nelle acque nazionaliste catalane, come se l’indipendenza catalana avesse molto di più da offrire ai lavoratori e alle lavoratrici rispetto a un’altra linea di divisione all’interno della nostra classe. Ora affronteremo lo stesso problema in Scozia.
8) Il potere parlamentare e il potere statale sono due cose diverse
Supponiamo che un partito socialista riesca a entrare nel governo. L’idea di una strada parlamentare verso il socialismo trascura il fatto che “prendere il controllo del governo” e “avere il potere statale” sono due cose completamente diverse. Vi è una scarsa analisi dell’attuale struttura materiale e di classe sociale dello stato (amministrazione, funzionari pubblici, esercito) e della sua indipendenza dalla democrazia parlamentare; ad esempio, nonostante i cambiamenti nella sua forma esterna il nucleo materiale e la traiettoria dell’apparato statale russo (cioè strati sociali di persone impiegate nello svolgimento di funzioni statali) si è riprodotto dai tempi del regime zarista, attraverso la rivoluzione bolscevica, il terrore stalinista, Glasnost e Putin. Se vogliamo guardare più vicino a casa nostra [nel Regno Unito NdR], anche il riverito Tony Benn avrebbe dovuto capire (quando era Segretario di Stato per le industrie a metà degli anni ’70) come la lotta contro l’ala destra del partito laburista fosse un gioco da ragazzi rispetto alla lotta contro i “suoi” dipendenti pubblici.
9) Concentrandosi sullo scenario nazionale e sullo stato, il socialismo democratico tende a sottovalutare la relazione globale del capitale
Supponiamo che un partito socialista non solo riesca a entrare nel governo, ma riesca anche a dominare l’apparato statale. A causa del fatto che lo stato nazionale è l’elemento centrale della strategia per il socialismo democratico, il progetto si confronta immediatamente con la natura globale del capitale. Livelli più elevati di tassazione e altre imposizioni comporteranno una fuga di capitali tra le società globali. Il socialismo democratico risponde a tale questione proponendo ad esempio alleanze con le piccole imprese, come una sorta di fronte nazionale produttivo unito contro le multinazionali e la finanza. Abbiamo visto più volte come questa necessaria alleanza sposti il punto di vista ideologico verso il “patriottismo di sinistra” e altre stronzate. Se un governo laburista tentasse effettivamente di aumentare la tassazione e ridistribuire le attività, il risultato più probabile sarebbe una svalutazione della sterlina e un aumento dell’inflazione a causa di un deficit commerciale, che non può essere facilmente contrastato, data la composizione dell’agricoltura, del settore energetico, della manifattura. La nuova leadership della sinistra laburista – addestrata all’attivismo e al discorso politico e aiutata dalla sua influenza all’interno della leadership sindacale – sarà il miglior veicolo per dire ai lavoratori e alle lavoratrici di “lasciare un po ‘di tempo al nostro governo laburista”, per spiegare che “le società internazionali si sono alleate contro di noi” e che, nonostante l’inflazione, i lavoratori e le lavoratrici dovrebbero mantenere la calma e andare avanti; le lotte salariali saranno dichiarate eccessive o divisive o di coscienza economica ristretta. Abbiamo visto come, ad esempio, il governo Chavez in Venezuela abbia organizzato i “poveri urbani” contro gli scioperi delle/degli insegnanti che hanno richiesto salari più alti, denunciandoli come avidi e quindi responsabili della povertà di altre lavoratrici e lavoratori.
10) La lotta di classe non si sviluppa gradualmente
L’attenzione del socialismo democratico alla campagna elettorale e all’organizzazione ufficiale dei sindacati porta a un giudizio errato su come si sviluppa la lotta di classe. Storicamente le lotte di classe si sono sviluppate a passi da gigante – in una dinamica molto più complessa tra “organizzazione” e forze e fattori esterni. La convinzione che la lotta di classe si basi sull’organizzazione e la mobilitazione “passo dopo passo” spesso porta alla presenza di militanti di sinistra che ostacoleranno la futura ondata di lotta. A breve termine, coinvolgere i “leader della comunità” o il tuo parlamentare locale o fare affidamento sul sindacato o sull’apparato del partito per mobilitare o incoraggiare colleghi e colleghe lavoratori e lavoratrici, potrebbe sembrare utile. Ciò che inizialmente sembrava un trampolino di lancio si rivela un ostacolo: ad esempio, i mediatori [tra lavoratori e lavoratrici e padroni NdR] che si frappongono alle lotte o le illusioni create da forme esclusivamente simboliche di lotta. La sfida è trovare forme di lotta “passo dopo passo” che aiutino al momento, ma non pongano problemi a lungo termine. Nel loro bisogno di creare una trasformazione dell’azione delle lavoratrici e lavoraori (scioperi controllati, ecc.) sul campo in “pressione economica” per sostenere le politiche statali, gli organizzatori socialisti tendono ad avere paura del carattere spesso caotico e apparentemente spontaneo delle lotte. Corrono il pericolo di non comprendere che queste situazioni di rottura della normalità sono precisamente le situazioni in cui i lavoratori e le lavoratrici devono affrontare la loro responsabilità di riorganizzare la riproduzione sociale. Questi momenti sono gli snodi cruciali e i momenti di apprendimento pratico necessari in cui cambiamo le cose e noi stessi. Soffocare questo significa uccidere la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
11) Il socialismo democratico e la sua paura della lotta di classe incontrollata diventa il becchino della lotta perché indebolisce l’attività necessaria della classe lavoratrice per difenderla
Il fatto che il più grande partito socialista della storia – la SPD tedesca – accettasse per la prima volta di sostenere il governo tedesco nei crediti di guerra del 1914 e reprimesse i moti rivoluzionari dei lavoratori e delle lavoratrici dopo la guerra non fu un atto di tradimento. Ciò faceva parte di una strategia di lungo termine per ottenere il potere governativo e riformare l’economia nazionale – per cui le “avventure” rivoluzionarie dei lavoratori rappresentavano un rischio. Dopo aver indebolito l’autorganizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, la SPD ha dovuto affrontare la crisi globale del 1929, che ha limitato la sua strategia economica nazionale. La combinazione di questi due fattori – una classe operaia indebolita dalla tattica del governo e dall’impotenza nei confronti del capitale globale – ha portato la SPD ad aprire le porte alla svolta reazionaria più brutale nel 1933. Un altro esempio è il governo socialdemocratico sotto Allende in Cile nel 1973. Questo caso ci mostra come il rapporto tra movimenti della classe lavoratrice e governi di sinistra sia più complicato del quadro spesso meccanicistico della forza (movimento) e del contenitore-stabilizzatore (governo). Possiamo vedere che le prime riforme sociali furono introdotte da un governo di destra, che non riuscì a contenere la lotta di classe. Quando Allende subentrò, ebbe difficoltà a tenere sotto controllo le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici e delle persone povere, lotte che avrebbero potuto essere incoraggiate dal nuovo governo di sinistra. Allende temeva che le forze imperialiste locali dell’alta borghesia e quelle internazionali avrebbero usato il conflitto sociale come scusa per l’intervento. I disordini nell’industria hanno anche creato carenze che hanno minacciato di destabilizzare ulteriormente il governo. L’andamento dei prezzi a livello internazionale, in particolare dei prodotti minerari, ha limitato le possibilità di concessioni materiali nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in sciopero. Le politiche di Allende nei confronti dei disordini della classe lavoratrice – che andavano dalle concessioni alla repressione militare – minarono e disarmarono letteralmente la classe operaia. Quando l’esercito locale, appoggiato dalla CIA, cominciò lo sterminio, la resistenza era già indebolita. Questo esempio storico sembra irrilevante per la situazione del Regno Unito o degli Stati Uniti di oggi, ma una volta che guardiamo oltre gli obiettivi a breve termine della tattica elettorale, affrontiamo ancora le stesse dinamiche fondamentali.
12) La strategia deve partire dalle lotte reali e dalle potenzialità e difficoltà reali imposte dal processo di produzione sociale
Abbiamo bisogno di strategie e abbiamo bisogno di organizzazione. Dobbiamo iniziare analizzando le condizioni e le relazioni reali della nostra classe: come è organizzata la produzione oggi, come è organizzata oltre i confini aziendali o nazionali, come siamo divisi come lavoratori e lavoratrici dal lavoro intellettuale e dalle conoscenze e come possiamo superare queste divisioni? Come possiamo avvalerci del fatto che i lavoratori e le lavoratrici cooperano lungo le filiere, spesso usando le moderne tecnologie di comunicazione per sviluppare nuove forme di organizzazioni transnazionali di lotta? In che modo oggi la nostra classe guida le sue lotte, dove utilizziamo i potenziali della produzione moderna e dove non riusciamo a usarli a nostro favore? In che modo le lotte nei luoghi di lavoro e nei settori industriali più grandi si collegano ad aree o regioni in cui i lavoratori e le lavoratrici sono più atomizzate? Dobbiamo creare una dinamica tra il potere industriale e sul posto di lavoro e l’inventiva delle persone della classe operaia per organizzare la loro sopravvivenza, sia sotto forma di cooperative, hack-lab, squat o progetti di comunità autogestiti. All’interno di queste lotte dobbiamo sviluppare l’organizzazione e la strategia per immaginare un controllo coordinato dei mezzi centrali di produzione, della loro difesa e della loro socializzazione oltre i confini nazionali. Ciò non accadrà nel giorno X di nostra scelta – ciò accadrà con la crescente disfunzionalità di questo sistema a cui contribuiranno le nostre lotte per la sopravvivenza. Il socialismo democratico e le sue strategie non saranno adeguati per la vastità, la durezza e la gioia di ciò che ci aspetta come classe lavoratrice.
Abbiamo visto che la strategia del socialismo democratico si scontra con le due principali forze storiche del capitalismo. In primo luogo, concentrandosi sull’arena nazionale si scontra con il carattere globale del capitale. In secondo luogo, riducendo la questione dello sfruttamento alla questione se i lavoratori e le lavoratrici operano sotto il comando privato o pubblico, la sua strategia si scontra con il sostanziale malcontento della classe lavoratrice. Un governo socialista sarebbe costretto a indebolire la propria base di potere per far fronte al continuo malcontento (“Mantieni la calma e concedi un po’ più di tempo al tuo governo dei lavoratori e delle lavoratrici”). A lungo termine questo crea disillusione e la base materiale per una svolta reazionaria. Questa è la lezione della storia.