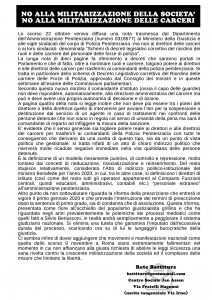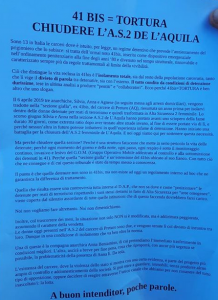da https://crimethinc.com/2019/11/13/lebanon-a-revolution-against-sectarianism-chronicling-the-first-month-of-the-uprising
Dal 17 ottobre, il Libano ha assistito a manifestazioni a livello nazionale che hanno rovesciato il primo ministro e trasformato la società libanese. Queste manifestazioni fanno parte di un’ondata globale di rivolte (tra cui Ecuador, Cile, Honduras, Haiti, Sudan, Iraq, Hong Kong e Catalogna) in cui gli sfruttati e gli oppressi stanno sfidando la legittimità dei loro governanti. In Libano, un accordo settario di condivisione del potere risalente alla fine della guerra civile ha creato una classe dominante di signori della guerra che usano il clientelismo per mantenere il potere vincendo le elezioni, confermando la nostra tesi secondo cui la politica è guerra con altri mezzi. In questo resoconto completo degli eventi del mese scorso, un partecipante sul campo descrive dettagliatamente la rivolta libanese, analizzando come abbia minato le strutture patriarcali e trasceso le divisioni religiose per riunire le persone contro la classe dominante.
di Joey Ayoub
Come tutto ha avuto inizio
Per il popolo libanese, la settimana del 17 ottobre 2019 è stata tra le più movimentate della memoria recente.
Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, gli incendi hanno devastato il Libano e parti della Siria. Abbiamo perso fino a 3.000.000 di alberi (1200 ettari) in un paese di 10.500 chilometri quadrati (4035 miglia quadrate), quasi raddoppiando la media annuale della perdita di alberi in sole 48 ore. La risposta del governo è stata disastrosa. Il Libano aveva solo tre elicotteri, donati da civili che li avevano messi a disposizione, lasciati fermi in aeroporto perché il governo non aveva fatto la manutenzione. Sebbene il governo avesse stanziato fondi per la manutenzione, i soldi erano “scomparsi”, come accade per molti fondi in Libano che sono nelle mani della classe dominante settaria. Alla fine gli incendi sono stati domati dall’intervento congiunto di impiegati pubblici volontari (la protezione civile non è pagata da decenni) tra cui persone provenienti dai campi profughi palestinesi, volontari a caso, aerei inviati da Giordania, Cipro e Grecia e, fortunatamente, dalla pioggia. Sarebbe potuto andare molto, molto peggio.
Non soddisfatti della propria incompetenza, i politici libanesi hanno fatto fare da capro espiatorio ai siriani, diffondendo voci secondo cui i siriani stavano appiccando gli incendi e si stavano trasferendo in case libanesi abbandonate (evidentemente i siriani sono a prova di fuoco…). Alcuni dei maggiori politici, come il capo del Movimento patriottico libero (FPM) Mario Aoun, si sono lamentati del fatto che gli incendi hanno colpito solo le aree cristiane, ignorando il fatto che la regione Shouf, dove sono avvenuti molti degli incendi, è in realtà una zona a maggioranza drusa.
Invece di affrontare le ripercussioni degli incendi e prevenire quelle successive, lo stato ha esacerbato la situazione. Il 17 ottobre, lo stato ha approvato un disegno di legge per tassare le telefonate via Internet tramite servizi come WhatsApp. Lo hanno definito come un tentativo di ottenere entrate aggiuntive per sbloccare oltre 11 miliardi di dollari di “aiuti” promessi alla conferenza CEDRE (Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises, ndt) a Parigi:
“Il vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nordafrica Ferid Belhaj ha affermato che se il Libano volesse vedere presto i soldi del CEDRE, dovrebbe prendere sul serio l’attuazione delle riforme”.
Queste “riforme” erano essenzialmente misure che punivano ulteriormente la maggioranza di meno abbienti, salvando la minoranza di ricchi.
Il Libano aveva già subito una serie di crisi economiche legate alla corruzione e al debito nazionale – la maggior parte del quale (circa il 90%) è detenuto dalle banche locali e dalla banca centrale – provocando corse agli sportelli bancari, carenza di carburante e scioperi. Quasi 90 miliardi di dollari sono concentrati in soli 24.000 conti bancari in Libano, vale a dire qualcosa tra i 6000 e gli 8000 titolari di conti in Libano hanno oltre otto volte la quantità di denaro che il governo spera di “sbloccare” con CEDRE. Sebbene molti media si siano concentrati sulla cosiddetta “tassa di WhatsApp”, in realtà è stata la combinazione di tutti questi fattori e molti altri a ispirare l’indignazione.
La notte del 17 ottobre, migliaia di persone sono scese nelle strade delle città del Libano, tra cui Beirut, Tiro, Baalbek, Nabatiyeh, Saida e molti altri luoghi in proteste spontanee. Le proteste sono state così partecipate che lo stato ha annullato immediatamente l’imposta. Quella notte, una donna di nome Malak Alaywe Herz ha preso a calci la guardia del corpo armata di un politico; il video è diventato virale e, come in Sudan, una donna è diventata un’icona rivoluzionaria. Entro il 18 ottobre, parti del centro di Beirut erano in fiamme e gran parte del paese era completamente chiuso da blocchi stradali, molti dei quali erano fatti con pneumatici incendiati.
Da quel momento mi sono unito alle proteste di Beirut e da allora ci vado quasi tutti i giorni. Come organizzatore delle proteste del 2015, cresciuto in Libano e che ne ha scritto dal 2012, ho capito subito che queste proteste sarebbero state diverse. Non ero l’unico preso da quel sentimento raro: la speranza. Al contrario, essa era ovunque. In questo resoconto, cercherò di spiegare perché queste proteste hanno già creato cambiamenti irreversibili nel paese, cambiamenti che le élite al potere dei signori della guerra e degli oligarchi stanno lottando per invertire.
La duplice natura dell’insurrezione
È importante considerare come l’insurrezione in corso abbia dimensioni sia riformiste che rivoluzionarie. È una rivolta contro l’ingiustizia e la corruzione e una rivoluzione contro il settarismo.
La dimensione riformista assume la forma di proteste contro la corruzione. Una richiesta comune, espressa nel canto kellon yaani kellon (“tutti significa tutti”), è che il governo si dimetta. Il 20 ottobre, quattro ministri associati alle forze libanesi (LF), un partito guidato dall’ex signore della guerra Samir Geagea, si sono dimessi; da allora, la LF ha cercato, piuttosto senza successo, di cavalcare l’onda delle proteste. La prima grande vittoria sono state le dimissioni del primo ministro Saad Hariri martedì 29 ottobre, facendo crollare efficacemente il governo come lo avevamo conosciuto, anche se, al momento della stesura di questo documento, è ancora il primo ministro custode [tecnicamente in carica, ndt].
Non ci sono richieste unificate provenienti dalle strade; in molti modi, c’è resistenza alla formulazione di un elenco di richieste. Detto questo, ci sono diverse richieste popolari, che richiedono principalmente la fine della corruzione e la politica settaria, che sono giustamente viste come intrecciate. Le vediamo nelle interviste di strada condotte dalle stazioni televisive, sui social media e tra i manifestanti stessi. Come hanno scritto Kareem Chehayeb e Abby Sewell, oltre alle dimissioni del governo, due richieste comuni sono state per “elezioni parlamentari anticipate con una nuova legge elettorale, per elezioni che non si basino sulla proporzionalità settaria” e “per un’indagine indipendente su furto e appropriazione indebita di fondi pubblici “. Quest’ultima richiesta è stata brevemente sintetizzata da un uomo di Arsal: “Non c’è una guerra. Si tratta di soldi. Hai rubato i soldi, restituisci i soldi”.
Le proteste sono anti-settarie in molti modi diversi. Trascendono ciò che potremmo pensare come una divisione sinistra/destra e includono persino i sostenitori tradizionali dei partiti politici settari. Questa rabbia è in atto da quasi tre decenni; i traumi intergenerazionali sono ancora più antichi. Dalla fine della guerra civile, la classe transnazionale dei signori della guerra-oligarchi del Libano ha perfezionato le regole del gioco. Lo stato funge da base attraverso la quale questa classe può fare affari con se stessa e principalmente con le élite del Golfo, dell’Iran e dell’ovest; le reti clientelari mantengono strutture di potere a beneficio di questa classe, mantenendo i segmenti della popolazione dipendenti da loro; le infrastrutture pubbliche sono state lasciate marcire mentre la rapida privatizzazione limita la libertà di movimento tra le regioni e paralizza regolarmente l’intero paese; e, più recentemente, la paura della violenza che trabocca dalla Siria è stata regolarmente evocata, tre decenni dopo la stessa guerra civile del paese, per imporre il senso di impotenza al popolo libanese.
Per farla breve: mentre cercavano di riprendersi da 15 anni di guerra civile, gli abitanti del Libano hanno trascorso gli ultimi tre decenni a barcamenarsi nella vita di un paese in cui avevano ben poco diritto di parola. Un’implosione era inevitabile, ma il modo in cui è accaduta sta sfidando le interpretazioni più ciniche della vita politica libanese, comprese quelle degli stessi libanesi.
Reclamare le nostre strade
Quando la guerra civile finì sotto la “tutela” (leggi: occupazione) del regime siriano, i poteri si sono ricomposti per creare una parvenza di politica al fine di promuovere il messaggio che gli anni ’90 sarebbero stati il decennio della ricostruzione. A Beirut ciò ha comportato la privatizzazione praticamente di tutto. Il centro storico, che gli arabi di tutta la regione chiamano Al-Balad (letteralmente “il paese”) è stato trasformato in Solidere, la società privata fondata dalla famiglia Hariri. Questo “neoliberismo realmente esistente” era addolcito da un discorso ottimistico: la narrazione era che solo attraverso legami commerciali si poteva tenere a bada la minaccia della guerra civile. Questo era il tempo in cui nacque la nostra generazione, la generazione del dopoguerra che mi piace chiamare la “generazione del ripensamento”. Siamo cresciuti ascoltando storie dei “bei vecchi tempi” prima della guerra, quando Beirut aveva una linea del tram e le persone potevano vendere merci negli spazi pubblici. Inutile dire che quel quadro roseo degli anni prebellici non considerasse le molte crisi avvenute a livello regionale e nazionale, crisi che alla fine hanno portato alla guerra civile nel 1975.
Ma gli anni ’90 hanno visto anche altri sviluppi. Il parlamento ha approvato una legge di amnistia nel 1991, perdonando la maggior parte dei crimini commessi durante la guerra, consentendo a coloro che avevano il potere di entrare nel governo. La maggior parte degli attuali pesi massimi della politica erano signori della guerra o imparentati con i signori della guerra, oppure divennero attivi nell’era postbellica o nei suoi primi giorni o dopo la Rivoluzione dei cedri del 2005 che espulse l’esercito siriano.
Queste figure politiche includono Nabih Berri, leader del movimento Amal dagli anni ’80 e presidente del parlamento dal 1992; Michel Aoun, presidente della repubblica, leader del Free Patriotic Movement (FPM) tornato dall’esilio nel 2005, e suocero di Gebran Bassil, che è anche leader dell’FPM e ministro degli esteri; Samir Geagea, leader delle forze libanesi (LF) dagli anni ’80, liberato dal carcere nel 2005 e rivale storico di Aoun; Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah dal 1992; Walid Jumblatt, leader del Partito progressista “socialista” (PSP) dal 1977; e Samy Gemayel, leader del partito Kataeb e nipote di Bachir Gemayel, un signore della guerra assassinato nel 1982 mentre era presidente eletto. Inoltre, possiamo considerare Saad Hariri, leader del Future Movement (FM), ripetutamente primo ministro [Hariri è stato in carica come primo ministro dal 9 novembere 2009 fino al 13 giugno 2011 e poi di nuovo dal 18 dicembre 2016 al 29 ottobre 2019, ndt] e figlio del primo ministro assassinato Rafik Hariri, come uno degli oligarchi più importanti dell’era postbellica, insieme a Tammam Salam, ex primo ministro e figlio di Saeb Salam, sei volte primo ministro prima della guerra civile, e Najib Mikati, anche lui ex primo ministro e di solito citato come l’uomo più ricco del Libano.
In breve, il Libano è governato da dinastie politiche che sono state forgiate nel fuoco della guerra civile o durante la sua “ricostruzione” del dopoguerra. Questo è ciò che i manifestanti nella città settentrionale di Tripoli hanno denunciato il 2 novembre con il canto “noi siamo la rivoluzione popolare, voi siete la guerra civile”.
Tripoli, la luce della rivoluzione
Tripoli, la più grande città del Libano settentrionale, è stata in prima linea nella rivolta. Quasi ogni giorno dal 17 ottobre, migliaia di manifestanti a Tripoli sono scesi in piazza per chiedere la caduta del regime settario. Per citare un manifestante di 84 anni, “C’è così tanta povertà e privazione qui che non importa come andrà a finire, le cose andranno comunque meglio”. Oltre alle spettacolari esibizioni di mobilitazione popolare, Kellon Yaa Kellon e “la gente vuole la caduta del regime” risuonano quotidianamente.
Tripoli, una città a maggioranza sunnita, ha apertamente sfidato la narrazione settaria dichiarando che sta con Nabatiyeh, Tiro e Dahieh, tutte città a maggioranza sciita. Quando Hezbollah e Amal Shabbiha (criminali governativi) hanno attaccato i manifestanti a Nabatiyeh il 23 ottobre, Tripoli ha risposto “Nabatiyeh, Tripoli è con te fino alla morte”. Il canto “Rivoluzione popolare contro guerra civile”, rapidamente adottato nel resto del Libano, presenta una narrazione in cui coloro che ancora si aggrappano alle loro identità settarie come reliquie della guerra civile si oppongono a coloro che stanno cercando di costruire un futuro inclusivo di tutti indipendentemente dalle sette religiose. Le proteste di Tripoli hanno indicato dall’inizio che questa rivolta sarebbe stata diversa.
Tripoli ha mantenuto uno slancio diverso a causa delle strutture organizzative emerse. Come a Beirut, i manifestanti a Tripoli hanno allestito ospedali e forum di discussione delle persone oltre a occupare l’edificio comunale. Le mobilitazioni sono state così inclusive che, per la prima volta che ne sono a conoscenza, i manifestanti di altre parti del Libano sono andati a Tripoli per partecipare alle proteste, in risposta a un invito aperto. Il 22 ottobre, poco prima che i manifestanti iniziassero a cantare “la gente vuole la caduta del regime”, un uomo con un megafono ha dichiarato “se [il governo] chiudesse tutte le piazze, siete tutti benvenuti in Nour Square [la piazza principale]”. Per la prima volta, Tripoli è diventata il centro dell’indignazione nazionale libanese. Nour significa “luce” in arabo; lo scrittore libanese Elias Khoury ha chiamato Tripoli la luce della rivoluzione.
Per cogliere il significato di tutto ciò, è necessario capire che parti di Tripoli e il distretto di Akkar a nord di essa hanno storicamente sopportato il peso maggiore della violenza statale mentre venivano demonizzate dall’opinione pubblica e dai media come snodi dell’estremismo sunnita. Sia lo stato libanese che Hezbollah hanno adottato le proprie versioni della narrazione post guerra dell’11 settembre, e le aree a maggioranza sunnita del Libano settentrionale, tra le più povere del Libano e vicine alla Siria, sono diventate capri espiatori. Eppure, nonostante questi tentativi da parte dei partiti settari, la creazione di questo capro espiatorio del Nord non è riuscita a ostacolare questo movimento. Si possono trovare commenti settari online, di solito mescolati con commenti anti-rifugiati, ma non hanno influenzato in modo significativo lo slancio visto per le strade.
Questo è il motivo per cui lo status di Tripoli come capitale de facto della rivoluzione ha messo a disagio attori politici come l’FPM. La stazione televisiva di FPM, OTV, ha regolarmente demonizzato i manifestanti a Tripoli e Akkar, impegnandosi in una campagna di disinformazione sin dall’inizio. Un titolo affermava che Tripoli stava “copiando” la città siriana di Homs (brutalmente schiacciata dal regime di Assad nel 2014), suggerendo che i militanti di Idlib si stessero facendo strada. Un altro esperto di OTV ha proclamato “proprio come siamo andati in Siria e seppellito la loro rivoluzione, seppelliremo questa rivoluzione in Libano” (L’FPM non ha mai partecipato militarmente in Siria, ma ovviamente lo ha fatto il suo alleato Hezbollah). Quando un attivista a Beirut ha risposto ai sentimenti dei rifugiati anti-siriani cantando “Bassil out, rifugiati in”, OTV ha preso quel filmato e ha aggiunto il titolo “Formazione americana, incitamento saudita, infiltrazione siriana”.
La connessione con la Siria è profonda. I manifestanti a Tripoli hanno cantato “Idlib siamo con te fino alla morte”, in riferimento alla città siriana che continua ad essere bombardata dalle forze aeree russe e siriane; I canti siriani sono stati adottati e riproposti in tutto il Libano. Come ha scritto un attivista siriano, “l’establishment politico del Libano, in particolare la parte che è ancora al potere, è sempre più infastidito da Tripoli e fa di tutto per mettere in cattiva luce la città e i suoi abitanti”. Il capro espiatorio di Tripoli potrebbe essere visto come un’estensione della risposta del governo libanese alla rivoluzione siriana, in particolare da parte di Hezbollah, Amal e FPM. Sebbene ufficialmente non affiliato, il governo libanese ha preso una piega dura contro i rifugiati dall’elezione di Aoun nel 2016, non che il governo fosse pro-rifugiati prima. In particolare Bassil si è associato a questa retorica, da cui il canto pro-rifugiato anti-Bassil.
Il distretto di Akkar è stato senza dubbio il capro espiatorio di politici e media anche più di Tripoli. Sebbene le proteste siano iniziate insieme al resto del Libano, la copertura mediatica rimane minima. Il 30 ottobre, i manifestanti ad Akkar, come altrove nel paese, hanno fatto eco al famoso canto siriano “yalla erhal ya Bashar” (affrettati a lasciare, Bashar [Assad]), adattandolo a “yalla erhal Michel Aoun”, come ascoltato per la prima volta in Beirut. Quella stessa notte, le forze di sicurezza hanno attaccato una marcia ad Akkar mentre i manifestanti cercavano di bloccare le strade. La risposta violenta delle forze di sicurezza ha portato i manifestanti a contrapporre la risposta relativamente mite delle forze di sicurezza di Beirut alla loro risposta ad Akkar.
La sollevazione del sud e dell’est
L’altra parte della storia è ambientata nel sud, in particolare a Nabatiyeh e Tiro (nota come Sour in arabo), così come nella valle della Bekaa ad est.
I manifestanti a Nabatiyeh sono stati tra i primi a manifestare la notte del 17 ottobre. Entro il 18 ottobre alcuni stavano già sfidando tabù di vecchia data. Il solo suggerimento che un manifestante ha fatto in diretta televisiva che Nabih Berri, il cui movimento Amal domina politicamente la regione accanto a Hezbollah, sia stato per troppo tempo presidente del parlamento – ha terrorizzato il giornalista che lo intervistava; il tweet che documenta questo fatto è stato eliminato. Per capire perché ciò sia accaduto e perché ciò che sta accadendo nel Sud e nell’est sia così importante, dobbiamo discutere della shabbiha.
La shabbiha è stata storicamente un fenomeno siriano. La parola stessa deriva da “fantasma” o “ombra”; è spesso associata alle Mercedes nere S600 (chiamate al-shabah) che sono state usate per rapire dissidenti e manifestanti siriani. Più tardi, il termine assunse una connotazione più generale, descrivendo gli uomini disposti a essere violenti in nome dei loro zu’ama (singolare: za’im), signori della guerra o capi principali locali, che spesso ricevono ordini dall’alto. Questo può significare qualsiasi cosa, dal picchiare i manifestanti a rapirli, torturarli e persino ucciderli. Quest’ultimo fatto non è più così comune in Libano, motivo per cui il termine shabbiha ora descrive qualsiasi attore filo-governativo disposto a infliggere violenza sui manifestanti.
Questa immagine [https://twitter.com/joeyayoub/status/1185511737317056512] ad esempio, mostra una banda shabbiha pro-Amal a Tiro il 19 ottobre; un video [https://twitter.com/chehayebk/status/1185506613584650240] di quella stessa mattina mostra queste shabbiha che attaccano i manifestanti. A causa della loro natura, è spesso molto difficile identificare la shabbiha e quasi impossibile “dimostrare” una catena di comando. Ma per motivi sia storici che contemporanei, sono state associate al Movimento Amal e a Hezbollah (sebbene la shabbiha armata di FPM abbia anche attaccato i manifestanti in almeno un’occasione).
Anche se Beirut ha subito due grandi attacchi della shabbiha, vale la pena notare che pure gli eventi del 29 ottobre, quando centinaia di uomini Amal/Hezbollah sono andati nel centro di Beirut per picchiare manifestanti e giornalisti e distruggere le tende allestite da manifestanti, impallidiscono rispetto a ciò che si sta diffondendo nel sud. Il 23 ottobre Amal/Hezbollah shabbiha ha attaccato i manifestanti a Nabatiyeh, ferendone oltre 20. Ciò ha così scioccato i manifestanti che una mezza dozzina di membri del consiglio comunale si sono dimessi il giorno successivo sotto pressione. In risposta all’attacco del 23 ottobre, il 24 ottobre è stato chiamato “il giorno della solidarietà con Nabatiyeh” e un meme è stato diffuso con le parole “Nabatiyeh non si inginocchia, chiedi ai sionisti”. Nella “Domenica dell’Unità” (3 novembre), i manifestanti a Kfar Remen, storicamente noti per la loro resistenza comunista all’occupazione israeliana nel Libano meridionale, hanno incontrato i manifestanti di Nabatiyeh. Alcuni manifestanti in fuga dalla polizia affiliata a Hezbollah di Nabatiyeh sono andati a Kfar Remen per unirsi alle proteste.
Questa è una svolta straordinaria per una regione del Libano che è spesso considerata il territorio incontrastato di Hezbollah e Amal; lo stesso vale per la valle della Bekaa. Ma le sfide alle potenze dominanti sono continuate. Abbiamo ascoltato canti come “Non vogliamo un esercito in Libano tranne quello libanese” (una sfida all’attuale potere militare dominante, Hezbollah), nonché solidale con Tripoli e il resto del Libano. Abbiamo visto la violenza della shabbiha a Bint Jbeil, una città al confine meridionale che ha sofferto molto sotto l’occupazione israeliana e poi durante la guerra del 2006. Tiro si unì anche la prima sera, cantando “la gente vuole la caduta del regime”; entro il 19 ottobre, la shabbiha stava attaccando violentemente i manifestanti. I giornalisti sono stati costretti a fuggire dalla scena mentre la shabbiha picchiava indiscriminatamente chiunque sulla sua strada. Un testimone ha descritto come la mukhabarat (polizia segreta) seguiva i manifestanti accanto alla shabbiha.
Per quanto riguarda la valle della Bekaa, la copertura mediatica è stata relativamente bassa. Ci sono state proteste a Zahleh, Baalbek, Taalbaya, Bar Elias, Saadnayel, Chtoura, Majdal Anjar, Al-Fakeha, Hasbaya, Rashaya e Al-Khyara, tra gli altri luoghi.
Le reazioni a questi attacchi della shabbiha furono un primo segno della rottura della proverbiale barriera della paura. I manifestanti a Beirut hanno cantato “Tiro, Tiro, per te noi risorgeremo” (che fa rima in arabo), uno slogan che è diventato rapidamente comune in tutto il paese.
Da allora, abbiamo visto ripetersi uno schema ormai familiare: la repressione è seguita dalla resistenza, che a volte è seguita dai sostenitori settari che si presentano in gran numero, ma altre volte porta i dimostranti a prendere il sopravvento. Questa è una parte importante della rivolta; c’è anche un chiaro tentativo da parte dei manifestanti di “convertire” i sostenitori del partito settario sotto lo stendardo unificato della politica anti-settaria. Fino ad ora, ciò si è rivelato relativamente efficace: mentre non possiamo mai valutare chi sostiene ufficialmente i partiti settari e chi no, prove aneddotiche e testimonianze dirette suggeriscono che la maggioranza della popolazione sia almeno d’accordo con il malcontento più ampio che motiva i manifestanti.
L’Establishment risponde
Questi attacchi potrebbero essere descritti come la parte fondamentale della strategia del governo di usare il bastone e la carota. Per quanto riguarda la parte della carota, è stata piuttosto confusa. Gli attori principali [dell’Establishment, ndt] hanno cercato di offrire una risposta coerente alle proteste, soprattutto perché non sono d’accordo tra loro e stanno provando, come al solito, a navigare a vista basando la propria politica giorno per giorno. La natura decentralizzata e orizzontale delle proteste ha ostacolato i tentativi dello stato di demonizzarle o cooptarle.
Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, ha tenuto un discorso il 19 ottobre. Al momento della stesura di questo documento, Nasrallah ha già parlato quattro volte dall’inizio della rivolta, un fenomeno insolito in sé. Sebbene Nasrallah non detenga una posizione ufficiale nel governo libanese, è visto come un regista di fatto a causa del potere militare di Hezbollah. Ma nonostante abbia una reputazione tra i suoi seguaci di essere relativamente sobrio nei suoi discorsi, il suo primo discorso è stato caratterizzato da autentica rabbia, arroganza e condiscendenza. Ha detto direttamente ai manifestanti che stanno sprecando il loro tempo e che questo “mandato” (la sua scelta di parole potrebbe anche essere tradotta come “era” o “patto”) non cadrà, in riferimento all’accordo del 2016 che ha portato Michel Aoun a diventare il presidente e Saad Hariri a diventare Primo Ministro (Ricordiamo che Nabih Berri non ha lasciato la sua posizione di Presidente del Parlamento dal 1992). Ha persino accusato i manifestanti di essere finanziati da ambasciate straniere, portando i manifestanti a rispondere dicendo “Sto finanziando la rivoluzione”, che da allora è diventato un meme ed è apparso anche sui segnali stradali. Un videomaker libanese ha risposto pubblicando un video dello stesso Nasrallah che afferma che Hezbollah è finanziata al 100% e armata dall’Iran.
Mantenendo il sostegno al governo, Nasrallah ha messo il suo peso dietro due degli uomini più impopolari della politica libanese: Gebran Bassil dell’FPM e Saad Hariri dell’FM. Ciò ha rivelato l’establishment come opportunista e corrotto. Proprio come i partiti politici settari si sono uniti nel 2016 per sconfiggere Beirut Madinati [la lista civica “Beirut è la mia città” raggiunse il 40% ma arrivò dietro la coalizione dei partiti di governo, ndt] alle elezioni comunali, si sono nuovamente uniti per sconfiggere la rivolta popolare. Ma Nasrallah ha commesso un grave errore. Dicendo che questo governo non cadrà, ha aggiunto pressione su Hariri affinché si dimettesse. Hariri era già l’anello più debole di questa coalizione, poiché doveva fare appello ai suoi rivali, il FPM e Hezbollah, per rimanere al potere contro i desideri dei suoi stessi sostenitori. Il 29 ottobre Hariri alla fine si è dimesso, apparentemente sorprendendo Hezbollah. In tredici giorni, i manifestanti avevano imposto il crollo di un governo che aveva richiesto mesi e mesi per essere formato.
Nelle settimane dall’inizio della rivoluzione, la classe dei signori della guerra e degli oligarchi si è impegnata per affrontare una crisi che non aveva previsto.
Ma come detto sopra, altri partiti politici hanno cercato di cavalcare l’onda della rivoluzione. Ciò è stato particolarmente evidente con Geagea e la LF, la storica rivale della FPM – una rivalità che risale alle sanguinose battaglie di Geagea-Aoun durante la guerra civile e che fu riaccesa dopo il 2005. La LF ha visto un’occasione d’oro quando è iniziata la rivoluzione: abbandonando un governo impopolare, l’LF credeva di poter indebolire i suoi rivali, poiché entrambi i gruppi si appellavano agli stessi voti settari. Ci sono stati anche sostenitori di LF che hanno bloccato le strade; questo ha creato un enigma per i manifestanti antigovernativi. Dopo le dimissioni di Hariri, alcuni manifestanti preferiscono concentrarsi sui grandi attori attualmente al governo – Aoun e Berri, rispettivamente presidente e portavoce del parlamento – eppure lo slogan “kellon yaani kellon” continua a dominare le proteste. Nonostante ciò che i sostenitori dell’FPM/Amal/Hezbollah vogliono credere, l’LF non è popolare tra i manifestanti; ha un supporto trascurabile nella maggior parte dei luoghi che hanno visto le proteste. Vi è un forte consenso sul fatto che nessun partito politico settario sarà sostenuto, non importa quanto duramente ci provino.
È ancora troppo presto per sapere quali saranno i prossimi passi del governo. Al momento della stesura di questo documento, il governo del “custode” deve ancora nominare nuovi ministri e il parlamento ha in programma di discutere una legge che garantisca un’amnistia generale che copra reati quali abuso di autorità, negligenza e crimini ambientali. La situazione si sta sviluppando molto rapidamente.
Energia Creativa
Le proteste in Libano sono state incredibilmente creative. Gli studenti di Tripoli hanno usato le gru per portare altri studenti fuori dalle scuole; i panini distribuiti a Beirut sono stati etichettati “finanziati da Arabia Saudita/Francia/Stati Uniti” per deridere quelli che sostengono che i manifestanti siano finanziati da potenze straniere; uno dei tanti posti di blocco è stato trasformato in un salotto con divani, un frigorifero e persone che giocavano a calcio e compariva su AirBnB (gratuitamente); i manifestanti hanno occupato Zaitunay Bay, un lungomare privato costruito sulla costa rubata di Beirut, e hanno proiettato il film V per Vendetta (ovviamente il 5 novembre); le immagini dei leader settari sono state demolite e bruciate; la gente ha sbattuto le pentole, facendo eco ai cacerolazos del Cile, per le strade e dalle loro case; i volontari hanno istituito mense a Beirut e Tripoli; uno storico cinema abbandonato è stato recuperato e riproposto come cinema, aula e luogo di ritrovo per artisti; la gente formava una catena umana da nord a sud; i manifestanti che bloccavano le strade cantavano “baby squalo” a un bambino bloccato nel traffico; i manifestanti indossano regolarmente maschere di Guy Fawkes, Dalì e Joker; gli organizzatori hanno creato forum aperti per riunire i manifestanti di Tripoli, Saida, Nabatieh, Zouk, Aley e Beirut. I manifestanti hanno “bloccato” una stazione ferroviaria per scherzo, per evidenziare una questione importante: le ferrovie del Libano sono state distrutte durante la guerra civile e mai ricostruite. La privatizzazione degli anni ’90 è avvenuta a spese di spazi e servizi pubblici, motivo per cui gran parte delle proteste hanno cercato di rivendicarli, impegnandosi in azioni di guerriglia gardening e simili.
L’idea generale qui è che i manifestanti debbano reinventare costantemente le loro tattiche al fine di rendere difficile per lo stato tenere il passo. Ad esempio, è in corso un dibattito sull’efficacia dei blocchi stradali. L’obiezione principale è che i politici non vengano danneggiati dai blocchi tanto quanto le persone comuni che cercano di andare al lavoro o mandare i loro figli a scuola. Allo stato attuale, questa tattica è ancora in uso, ma non è più quella principale. Nei giorni scorsi, i manifestanti si sono trasferiti per occupare o protestare di fronte a edifici governativi e altri simboli del potere: tutto, dalle case dei politici alle centrali elettriche nazionali (la maggior parte del Libano non ha ancora elettricità 24/7), passando per le principali telecomunicazioni e operatori di dati, banche, comuni e così via. Ora ci sono dozzine di azioni diverse su base giornaliera, con la maggior parte delle azioni annunciate solo un giorno prima. Al momento della stesura di questo articolo, studenti delle scuole superiori e dell’università – e alcuni studenti ancora più giovani – hanno protestato per tre giorni a Saida, Beirut, Jounieh, Tripoli, Koura, Bar Elias/Zahleh, Mansourieh, Hadath, Baalbek, Nabatiyeh, Al-Khyara, Al-Eyn, Mazraat Yachouh, Furn El Chebbak, Akkar, Tannourine, Batroun e Byblos/Jbeil, tra gli altri luoghi.
C’è stato anche uno sforzo online per contrastare le false notizie diffuse dai sostenitori del governo e degli stessi partiti politici, nonché per aiutare i manifestanti a rimanere informati più in generale: el3asas (“la guardia della città”) sta verificando la diffusione delle notizie sui social media e dalle agenzie di stampa ufficiali; una piattaforma online chiamata Daleel Thawra (“directory della rivoluzione https://www.daleelthawra.com/”) sta tenendo traccia delle varie azioni, attività e iniziative; TeleThawra (“TV della rivoluzione”) offre un’alternativa al Télé Liban di proprietà del governo libanese; Fawra Media (“Outburst Media”) mira a documentare “le persone e i gruppi che sostengono la rivoluzione libanese”; Sawt Alniswa (“Voice of Women”) è una rivista a conduzione femminile pubblicata settimanalmente; e Megaphone News è uno dei principali media indipendenti dal 2017.
Onde d’urto sotterranee
Questi sviluppi hanno aperto uno spazio per le persone e le narrazioni che sono generalmente soppresse a livello nazionale o di partito.
Oltre ai suddetti attivisti, palestinesi e siriani hanno partecipato attivamente alle proteste, in particolare nelle due maggiori città, Beirut e Tripoli. Alcuni elementi dei media settari ne hanno approfittato per ribadire le loro accuse secondo cui le proteste sono “infiltrate da stranieri”. Consapevoli di ciò, da allora molti palestinesi e siriani hanno imparato a muoversi nella politica libanese, principalmente mantenendo un profilo basso. Oltre a una protesta nel campo profughi di Ain El Helweh, dove i palestinesi hanno espresso direttamente solidarietà con le proteste libanesi, i palestinesi di Saida, Beirut, Tripoli e altrove dove finora hanno partecipato, hanno fatto attenzione a “restare in disparte nelle manifestazioni libanesi per evitare di essere accusati di istigare o usurpare il movimento di protesta ”. Ciò, in particolare, ha reso più difficile per gli xenofobi giocare il loro solito gioco, dato che è impossibile distinguere tra popolo libanese, palestinese e siriano a meno che non agitino le loro rispettive bandiere nazionali. (Questo testo: https://globalvoices.org/2018/02/01/lebanons-scapegoating-of-refugees-did-not-start-with-syrians-but-with-palestinians/ offre alcune informazioni sulla tattica del capro espiatorio).
Abbiamo anche visto, in misura minore, i canti dei manifestanti in solidarietà con gli egiziani, i sudanesi e altre parti arabe del Medio Oriente e della regione del Nord Africa, e c’è una certa consapevolezza, per lo più espressa sui social media, delle proteste in corso e della violenza in Iraq, Hong Kong, Rojava e Cile. Anche se rapidamente dimenticate a livello nazionale, abbiamo anche assistito a rivolte il primo giorno nelle carceri di Zahle e Roumieh in solidarietà con i manifestanti, nonché per richiamare l’attenzione sulle orribili condizioni carcerarie del Libano e per ripetere la richiesta di una legge di amnistia generale, quando in molti casi le persone vengono arrestate per presunti legami con gruppi jihadisti, possesso di droga e così via.
Allo stato attuale, non vi è stata alcuna grande partecipazione da parte dei lavoratori domestici migranti, che sono generalmente confinati nelle case familiari libanesi oppure stanno languendo in orribili prigioni sotterranee con diritti politici minimi o nulli sotto il famigerato sistema Kafala (sponsorizzazione) del paese. È improbabile che ciò cambi nel prossimo futuro, date le restrizioni imposte loro, ma se lo slancio delle proteste continua, potrebbe aprire abbastanza spazio politico per formare nuove connessioni.
La rivoluzione è femminile
Fino ad ora, le proteste si sono concentrate sulla lotta alla corruzione diffusa e al sistema settario. Ma il ruolo delle femministe, tra cui LGBTQ+ e / o attiviste non libanesi, suggerisce un tentativo da parte dei segmenti di manifestanti di creare un movimento più progressista e inclusivo. Le femministe hanno tenuto marce separate per evidenziare le strutture patriarcali che opprimono in modo sproporzionato le donne e le persone LGBTQ+, in particolare il fatto che le donne libanesi non possono ancora trasmettere la loro nazionalità ai loro coniugi e figli e il fatto che le leggi settarie del paese che regolano tali affari come il matrimonio, il divorzio, la custodia e così via discriminino le donne. Sia le donne che gli uomini hanno marciato per il diritto di trasmettere la nazionalità, a Tiro, a Tripoli e altrove.
Le donne hanno anche usato i loro corpi per proteggere altri manifestanti dalla polizia [https://twitter.com/lebnenereine/status/1184908295770968064]e prevenire l’escalation della violenza. Come ha affermato Leya Awadat, una delle partecipanti a queste “mura femministe”, “In questa società sciovinista, si vede male che gli uomini picchino pubblicamente le donne” (con l’enfasi sulla parola “pubblicamente”), quindi lo hanno usato a loro vantaggio.
Anche le persone LGBTQ+ sono state oggetto di insulti omofobi. Uno shabbiha che ha attaccato i manifestanti il 29 ottobre è stato ascoltato in diretta televisiva urlare “Gli uomini sono fottuti uomini!” Un ospite della OTV ha affermato che i manifestanti vogliono distruggere il settarismo in nome di una sorta di “agenda gay”.
Le marce femministe si incontrano sempre con le marce principali. L’idea non è quella di creare movimenti separati, ma piuttosto di far conoscere la loro presenza all’interno delle più ampie richieste di giustizia e uguaglianza. Le femministe hanno guidato molti dei blocchi stradali e lanciato molti slogan, oltre a mantenere una presenza attiva nelle attività quotidiane che aiutano a mantenere lo slancio di questa rivolta. Un modo per riuscirci è riappropriarsi di slogan e canzoni, sia tradizionali che recenti, e rimuovere le loro connotazioni sessiste. La famosa canzone “hela hela” contro Gebran Bassil insulta sua madre – è molto comune nel mondo di lingua araba usare le donne o i loro genitali come insulti – quindi le femministe l’hanno cambiata per insultare sia Gebran che “suo zio” (il presidente, Michel Aoun), creando un canto che da allora ha preso piede. Si sono riappropriate anche di una canzone tradizionale usata per mandare le donne al matrimonio, cambiando il testo in “andò a protestare, andò a chiudere le strade, andò a far cadere il governo”.
Cosa accadrà adesso?
Contrariamente a quanto alcuni avevano ipotizzato, adesso “l’elefante nella stanza” non è più il settarismo. Mentre il rischio di tensioni settarie rimarrà probabilmente per il prossimo futuro, il rischio più immediato è l’incombente crisi economica. Secondo me, questo è il motivo per cui forme di lotta più radicali stanno emergendo solo timidamente. La paura che le cose peggiorino molto è realistica; è molto difficile parlare di modi alternativi di organizzarsi, anche trascendendo le meschine (e pericolose) distinzioni libanesi/non libanesi, quando la preoccupazione principale della maggior parte delle persone è la probabilità di ritrovarsi con la scarsità di medicine e carburante e forse anche di carenze alimentari. Mentre una politica più radicale può svilupparsi organicamente se la situazione economica peggiora, è anche possibile invece che si rafforzino gli elementi più nazionalistici e settari della politica libanese. Queste ultime tendenze hanno decenni di esperienza al potere, mentre le forme più aperte di politica sono relativamente nuove, appena costruite per le strade e online.
Di conseguenza, una percezione dominante tra i manifestanti è che dobbiamo essere sia arrabbiati che cauti.
Detto questo, le mense, i presidi sanitarii gratuiti e il recupero di siti storici e aree costiere privatizzati sono tutte iniziative che implicitamente affermano ciò che possiamo chiamare i beni comuni. Ciò è cruciale da comprendere in un paese che non ha avuto beni comuni nella memoria recente, dove l’ideologia “pro-mercato” dominante precede l’istituzione dello stato nazionale del Libano.
Sebbene si possa sostenere che gli attori principali siano all’incirca una dozzina di personaggi pubblici, la ragione per cui le reti clientelari hanno funzionato finora ha anche a che fare con l’esistenza di un sottogruppo della popolazione che beneficia di queste reti. Si posizionano come intermediari tra gli oligarchi e coloro che cercano wasta (bustarelle, nepotismo, “chi conosci”) per ricevere servizi non forniti dallo stato. In altre parole, alcune persone hanno incentivi finanziari per mantenere le reti clientelari contro la creazione di qualsiasi cosa che possa essere chiamata istituzione pubblica. Riformare e poi rovesciare un tale sistema sarà difficile. Rovesciare un tale sistema mentre ci si confronta con il brutale potenziale dello stato sarà ancora più difficile.
Ma se la libera coalizione di progressisti anti-settari non affronta questo problema, è probabile che lo stato farà fare da capro espiatorio a quelli che ha già preso di mira: rifugiati e lavoratori siriani e palestinesi, lavoratori domestici migranti (principalmente dall’Etiopia, dallo Sri Lanka e dalle Filippine, in modo schiacciante donne), persone LGBTQ+ (cittadine e non cittadine), prostitute e simili. Qualsiasi individuo che non si adatta al paradigma patriarcale-capitalista-settario è a rischio di violenza fisica, psicologica e simbolica.
Infine, e questo è collegato al punto precedente, sconfiggere il settarismo politico e “il modo settario di fare le cose” è visto come una priorità immediata. Questo sistema, che risale al 1860 in una sua manifestazione o in un’altra, sta perdendo la sua aura di essere intoccabile con le generazioni del dopoguerra, sia i Millennial che, in particolare, la Generazione Z – coloro che hanno vissuto per tutta la vita ascoltando i loro genitori lamentarsi “Dov’è il governo? ”quando devono pagare due bollette separate per l’elettricità (privata e pubblica) e tre bollette separate per l’acqua (acqua corrente pubblica e privata, acqua potabile privata in bottiglia). Man mano che i signori della guerra invecchieranno, (due dei più potenti, Aoun e Berri, hanno rispettivamente 84 e 81 anni) vedremo l’inevitabile declino del settarismo dell’era della guerra civile. Ma mentre questo potrebbe essere inevitabile, la domanda è se i progressisti anti-settari riusciranno a costruire alternative sostenibili che possano sfidare il vecchio ordine.