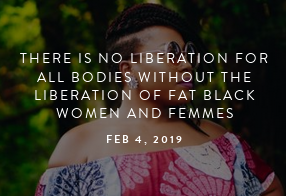Ho scelto di tradurre quest’articolo perché ho vissuto e vivo da vicino (e da diverse angolazioni) che cosa sia la psichiatria, e da abolizionista mi sono sempre chiesta perché le galere psichiatriche siano ancora ritenute da tantx così necessarie. Lo dedico ad Ennio: non sei più qui, ma le nostre chiacchierate sono anche in tutte queste righe. E sempre sarai in queste lotte. S.P.
di Stella Akua Mensah e Stefanie Lyn Kaufman-Mthimkhulu
Note sui contenuti: sanità mentale, razzismo, violenza, violenza di stato, incarcerazione, istituzionalizzazione, “trattamento” forzato, tortura, coercizione medica, moderazione, isolamento, abuso, violenza sessuale, colonialismo
C’è una storia pericolosa negli Stati Uniti, basata sul mito della deistituzionalizzazione dei manicomi1. Attraverso questa storia, ci viene detto che il manicomio è morto ed è una cosa del passato. Ci viene detto che, ora, i/le “pazienti” hanno diritti, sono trattati con dignità umana e non sono criminalizzatx per la loro neurodivergenza. Ci viene detto che le restrizioni e i farmaci forzati avvengono solo in casi “estremi”. Ci è stato detto che il sistema di cura della salute mentale è qui per aiutarci, sostenerci e “curarci”. E ora, quando l’abolizionismo è entrato nel discorso mainstream, ci viene detto che questo stesso sistema dovrebbe essere considerato un’alternativa all’incarcerazione nelle prigioni. Ma quellx di noi che sono sopravvissutx all’incarcerazione psichiatrica sanno che non solo il manicomio non è mai morto, ma è, ed è sempre stato, un’altra prigione. Conoscendo la verità di questi miti, lavoriamo per scrivere una nuova storia.
Come afferma Hussein Abdilahi Bulhan nel suo lavoro Frantz Fanon: The Revolutionary Psychiatrist, “la psichiatria come qualsiasi terapia dovrebbe essere l’incontro di due persone ‘libere”. Nella nostra società attuale, questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Ogni stato (e Washington DC) consente a una persona di essere trattenuta involontariamente per “trattamento, osservazione o stabilizzazione”. Sebbene le specifiche varino a seconda dello stato, le tre principali forme di impegno sono: ricovero d’urgenza per valutazione, ricovero ospedaliero involontario, cure ambulatoriali “assistite”. Ciò significa che altre persone possono decidere (senza il tuo consenso) che tu rappresenti un rischio per te stessx o per altrx e che devi essere rimossx o sorvegliatx all’interno della tua comunità per il “trattamento”. Sebbene le persone disabili abbiano combattuto instancabilmente per il nostro diritto a vivere nella comunità, come previsto dall’ADA 30 [Americans with Disabilities Act (ADA], dobbiamo riconoscere le numerose scappatoie esistenti che rendono la nostra reclusione involontaria in contesti congregati una realtà.
Mentre parliamo di abolizione della prigione, discorso che è stato ampiamente fondato e rimane guidato dalle rivoluzionarie donne nere, dobbiamo fare i conti con la storia della psichiatria e capire meglio come il sistema di salute mentale perpetua i processi di criminalizzazione, polizia e sorveglianza. Quando guardiamo più in profondità, possiamo vedere sorprendenti somiglianze tra carceri e istituzioni psichiatriche. Come ha descritto Leah Ida Harris, sia carceri che istituzioni psichiatriche: hanno una sovrarappresentazione di BIPOC (neri, indigeni e persone di colore), ignorano i diritti e la sicurezza delle persone TGNC (trans e di genere non conforme), utilizzano il trasporto/risposta delle forze dell’ordine, utilizzano la reclusione e l’isolamento nelle celle /”stanze”, medicano forzatamente le persone (note anche come restrizioni chimiche), usano restrizioni fisiche, offrono un accesso estremamente limitato alla luce solare, all’aria fresca, ai telefoni cellulari, alle notizie/ai media e al mondo esterno. Inoltre, la violenza sessuale è di routine, c’è un potere limitato di appellarsi a decisioni legali/mediche e la stragrande maggioranza dex detenutx sono sopravvissutx a precedenti esperienze traumatiche. Quest’anno, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha presentato un rapporto affermando che gli interventi psichiatrici involontari “potrebbero benissimo equivalere a tortura”.
La cultura carceraria non è risolvibile “finanziando il sistema di salute mentale” in modo più robusto. Il sistema di “salute” mentale è fondamentalmente carcerario, il che significa che è uno dei tanti sistemi affini che funzionano per contenere e sorvegliare le persone, togliere il loro locus of control, isolarle dalle loro comunità e limitare la loro libertà.
Poiché funziona in America e in tutti i luoghi toccati dal colonialismo, la psichiatria è radicata nella tortura, nella supremazia bianca e in una cultura della vergogna e della punizione. Sì, il manicomio vive e la polizia ama il manicomio.
Abolizionismo significa che tutte le gabbie vengono rimosse, comprese quelle che funzionano con il pretesto di “cure” psichiatriche.
L’abolizione della psichiatria non significa che a nessunx sia permesso identificarsi con diagnosi psichiatriche che ritengono essere loro utili, o che nessunx possa continuare a prendere farmaci psichiatrici che ritengono efficaci². Significa, tuttavia, che la nozione di “malattia mentale” è stata inventata per patologizzare le risposte logiche allo stress e ai traumi che sono onnipresenti in un mondo brutalizzato dal colonialismo e dal capitalismo. La psichiatria è stata descritta come una “colonizzazione medicalizzata di terre, popoli, corpi e menti”. Un notevole esempio delle intenzioni coloniali della psichiatria fu la diagnosi di “drapetomania”: la “malattia” mentale che spiegava perché le persone nere schiavizzate nell’Antebellum south scappavano dai loro campi di sterminio (il “trattamento” li considerava “come bambini”). Come afferma China Mills in Globalizing Mental Health, “il disagio causato dalle condizioni socio-economiche (e spesso dalle riforme economiche neoliberiste) viene riarticolato come ‘malattia mentale’, trattabile usando tecniche che attingono a motivazioni simili a quelle che inizialmente hanno portato allo stress.”
Abolizionismo psichiatrico significa che il risultato previsto e realizzato dell’avvento “malattia mentale” come significante è far sentire alle persone che non miglioreranno mai e che il loro disagio è inerente alla loro chimica cerebrale piuttosto che una reazione a stimoli esterni. Questa logica è essenzialmente victim-blaming e allontana la responsabilità dai cicli di violenza che creano le condizioni per la sofferenza psicologica – per non parlare del fatto che la teoria dello “squilibrio chimico” è stata ampiamente sfatata. Significa anche che la psichiatria è stata costruita con un desiderio fondamentale di disumanizzare, drogare e scartare coloro il cui comportamento e modi di essere sono divergenti dallo status quo. Questo status quo era ed è bianco, patriarcale e assolutamente innamorato della rispettabilità e del rispetto delle nozioni egoistiche dello stato di “normalità”.
Molti Psichiatrici Sopravvissuti hanno fatto passi da gigante nella ricerca della giustizia, delle riforme e talvolta dell’abolizionismo. Ma la natura attuale dei reparti psichiatrici, che, per la maggior parte, sono rimasti prigioni violente e degradanti in cui la maggioranza delle persone ex detenute afferma di non essere stata aiutata e di essere stata ulteriormente traumatizzata, indica probabilmente che il manicomio non è mai morto. Perché? Perché non è mai stato supposto. La psichiatria È l’etica del manicomio e il manicomio non cadrà finché non cadrà la psichiatria.
***
Le nostre discussioni sull’abolizionismo psichiatrico sono approfondite quando guardiamo alla storia della cultura carceraria nelle sue molteplici forme: polizia, pena di morte, eliminazione del dissenso e, al di sotto di tutto, una fedeltà alla nozione binaria per cui ci sono brave persone e ci sono persone cattive. La punizione e l’eliminazione dex “cattivx” e delle persone dissidenti non è solo un problema americano, ma le sue manifestazioni in questo paese sono uniche e inestricabilmente radicate nella schiavitù e nel genocidio delle persone nere e indigene. In Amerikkka, coloro che sono persone “buone” aderiscono (o si adattano naturalmente) allo status quo dello Stato, e sono utili ingranaggi nelle macchine gemelle della supremazia bianca e del capitalismo. All’interno della categoria “cattiva” dello stato ci sono quellx la cui utilità per lo stato è discutibile, che include in modo sproporzionato BIPOC, persone TGNC, persone LGBTQIA2S+, persone disabili e neurodivergenti, persone povere e coloro che tentano di ritenere lo stato responsabile della sua violenza.
È anche importante che parliamo di danni. Quando moltx di noi pensano alle istituzioni, pensiamo di mantenere la società al sicuro dax più dannosx tra noi. La verità è che tuttx noi causeremo danni nelle nostre vite, e sapere questo piuttosto che proiettarlo su determinati individui è molto importante per l’abolizionismo in modo da poter praticare l’antidoto alla punizione: la responsabilità. La cultura carceraria ci ha portato a negare la nostra capacità condivisa per l’intero spettro di danni, dando la priorità al “crimine” e definendolo in gran parte in termini di come interrompiamo l’”ordine” piuttosto che come ci danneggiamo a vicenda. La verità è che le strutture a cui dovremmo aderire per essere considerate “buone” sono alla radice dei cicli di violenza che creano le nostre capacità di danno. Non solo, ma le nostre ragionevoli reazioni alla violenza autorizzata dallo stato sono considerate “dannose”, attribuendo la colpa alle vittime. Sì, c’è molto danno nel mondo, ma se proviamo a immaginare un mondo in cui le strutture coloniali non abusino più delle nostre comunità mentre sponsorizzano felicemente cicli di violenza al loro interno, è possibile vederci guarire a livello interpersonale e comunitario in un modo che ha il potenziale per trasformarci andando oltre la cultura carceraria.
Vale la pena sottolineare che la cultura carceraria esiste nel nostro mondo da almeno 4.000 anni, con alcunx antropologx che datano a decine e persino centinaia di migliaia di anni fa la pena capitale. Tutto questo per dire: la cultura della prigione e della punizione sono abbastanza fondamentali per l’umanità. Denominare la prigionia per quello che è – antica – ci aiuta ad affrontare il colossale compito di guarire verso l’abolizione. Allo stesso tempo, ci sono state – e ci sono ancora – società e comunità che resistono a gerarchie e punizioni dannose. I popoli indigeni hanno usato cerchi di parola per migliaia di anni, “che incarnavano hozjooji naat’aanii, una frase navajo che significa “qualcosa di più di ‘persone che parlano insieme per riformare le relazioni tra loro e l’universo'”.Guardiamo a queste pratiche di giustizia riparativa (RJ) come guide venerate nella nostra ricerca abolizionista. Transformative Justice (TJ) è un’evoluzione di RJ che riconosce la nostra necessità di curare anche i sistemi di oppressione che causano in primo luogo il danno alle nostre relazioni.
La cultura carceraria diffusa nel mondo è in gran parte il risultato di una gerarchia di valori umani che è servita a lungo a semplificare la nostra reciproca comprensione. Se condividiamo effettivamente la capacità di nuocere, allora siamo tuttx degnx di entrare in contatto con le nostre capacità condivise di trasformazione. Se condividiamo anche la capacità di diverse manifestazioni di stress e neurologiche, dobbiamo eliminare il binario “sano di mente”/”folle” e darci il permesso di essere liberx e trovare la guarigione. Basati sugli insegnamenti di Restorative, Transformative e Disability Justice, crediamo fermamente che un mondo post-istituzioni sia possibile e in atto.
Non c’è modo per tuttx noi di essere liberx senza smantellare i sistemi riduttivi di controllo che impongono nozioni di normalità e correttezza al servizio dello stato, le cui conseguenze sono fatali per tantx di noi. Spiritualmente, possono essere fatali per tuttx noi.
La giustizia sulla disabilità e la giustizia riparativa e trasformativa ci chiedono di immaginare il mondo in cui vogliamo vivere, collettivamente e di mettere in pratica queste idee e valori ogni giorno. Queste strutture ci forniscono gli strumenti necessari per plasmare una società che supporta la nostra guarigione. Quando pensiamo a un mondo post-psichiatrico e post-carcere, vediamo pari camminare insieme attraverso la sofferenza e sviluppare abilità empatiche che favoriscono la reciprocità. Vediamo i processi di TJ che ci aiutano a resistere alla vergogna e alla punizione, ad accettare la responsabilità e a smantellare le tendenze interiorizzate al danno e all’abuso. Ci vediamo consapevoli che la nostra angoscia è una risposta comprensibile ai cicli di danno e sofferenza³. Ci vediamo trascorrere del tempo riposante e formativo con persone amorevoli in spazi amorevoli quando siamo in crisi. Ci vediamo curare il nostro trauma secondo i nostri ritmi e nei nostri modi. Non ci vediamo più patologizzare e diffamare manifestazioni belle e innocue della neurodiversità. Non ci vediamo mai, in nessuna circostanza, introdurre farmaci psichiatrici nel corpo dell’altro senza (leggi: non coercitivo) consenso. E, forse la cosa più fondamentale, ci vede che ci prendiamo effettivamente cura l’uno dell’altro, senza paternalismo e senza imprigioniarci a vicenda mentre ci riferiamo a questa violenza come “cura”. 4
Intorno a noi si stanno già evolvendo forme amorevoli e non carcerarie di assistenza comunitaria e risposta alle crisi, per aiutarci a scrivere questa storia post-carcere. Il progetto LETS fa questo lavoro ogni giorno, attraverso i nostri modelli Peer Mental Health Advocate (PMHA) che esistono al di fuori del complesso carcerario-industriale. Altri meravigliosi esempi includono: The Hearing Voices Network, Mad in America, Sins Invalid, Health Justice Commons, Western Mass Recovery Learning Community, HEARD, e molti altri. Le basi sono state gettate, ma insieme, dobbiamo fare il lavoro di costruire, immaginare e creare i nuovi mondi in cui vogliamo vivere. Come ha brillantemente affermato Frantz Fanon, “se è la società che è ‘malata’, allora è la “società che deve essere sostituita.”
Appunti
1 Ci riferiamo alla deistituzionalizzazione come a un mito perché non è mai stata pienamente realizzata. Sebbene le popolazioni all’interno degli istituti siano state ridotte, molte delle persone della nostra comunità sono ancora incarcerate in istituti psichiatrici, carceri, case di cura, case residenziali e altri ambienti congregati usati per far sparire le persone. Per ulteriore contesto, consigliamo: Decarcerating Disability di Liat Ben-Moshe.
2 Sebbene la psichiatria sia un sistema fondamentalmente violento, ci sono alcuni farmaci psichiatrici che sono efficaci per alcune persone (sebbene il trauma culturale e strutturale che crea manifestazioni angoscianti di neurodivergenze è necessario sia la priorità). Non siamo anti-farmaci e non sosteniamo che le persone interrompano l’assunzione di farmaci a loro utili. Crediamo, tuttavia, che la creazione e l’evoluzione degli psicofarmaci potrebbe essere concretamente rilevata da entità post-psichiatriche che si riconoscono/costruiscono sulla piccola saggezza che è uscita incidentalmente da questa struttura violenta.
3 Alcune manifestazioni di neurodivergenza non si sentono come risposte a traumi interpersonali o stress. A volte questo è perché sono risposte a traumi sistemici e stress che sono così onnipresenti che non ci rendiamo conto del loro impatto sulle nostre menti e corpi. A volte, questo è perché il trauma e lo stress vengono ereditati nel corpo dai nostri genitori e/o antenati. A volte non sappiamo da dove provenga la nostra angosciante neurodivergenza, e qui sta il valore dell’identificazione con una “malattia mentale”. A volte la nostra neurodivergenza non è in alcun modo angosciante e quindi non ha bisogno di spiegazioni. Puoi scegliere il linguaggio che descriva la tua esperienza. La nostra speranza è che tu permetta a te stessx l’esplorazione di come le diagnosi e i meccanismi psichiatrici possano toglierti la conoscenza di te stessx, facendo delle scelte per te.
4 Vorremmo anche confermare che alcune persone hanno avuto buone esperienze in istituti psichiatrici. Da un’ottica abolizionista, crediamo che le parti buone di quelle esperienze potrebbero essere replicate e migliorate all’interno dei centri di riposo e altre innovazioni negli spazi di guarigione non carcerari. Inoltre, dire che hai avuto una buona esperienza in un reparto psichiatrico e quindi la psichiatria non dovrebbe essere abolita è come dire che la polizia ti ha aiutato e quindi non dovrebbe essere abolita – il punto è che sei in minoranza, e la saggezza di coloro che hanno sofferto per mano di questi delinquenti sostenuti dalle istituzioni devono essere centrali.