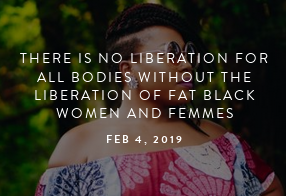La decolonialità non può essere l’ennesima retorica che ci dia una nicchia all’interno dei femminismi occidentalocentrici, un’identità che completi la ‘diversità’ di quel femminismo.
Di Salma Amzian e Natali Jesús
All’interno delle genealogie delle diverse comunità razzializzate esistono molte donne che hanno analizzato l’intreccio delle loro oppressioni, individuando come ostacolo la modernità occidentale e il suo falso universalismo. Quest’ultimo cerca costantemente e in forme sempre nuove di produrre astrazioni e essenzialismi per mantenere l’invisibilizzazione dei/delle disumanizzate della terra. Queste donne hanno riconosciuto rapidamente, in diversi linguaggi, la complessità delle oppressioni contro cui dovevano lottare; senza utilizzare i termini odierni la loro lotta era contro la colonizzazione dei propri corpi, delle loro menti, dei loro popoli e territori.
Violenza razzista istituzionale derivata dalla Ley de Extranjería
La ley de extranjería legittima il razzismo istituzionale e controlla i processi di regolarizzazione, ma soprattutto quelli di irregolarizzazione e di esclusione sociale delle comunità ‘altre’, non spagnole e bianche.
Nel contesto spagnolo Fatiha El Mouali, economista, ricercatrice e attivista antirazzista ha denunciato l’insieme di violenza istituzionale, economica e politica derivate dalla Ley de Extranjería che subiscono le donne marocchine migrate nello Stato spagnolo. Questa legge “subordina la situazione legale delle donne migranti marocchine (e tutte quelle provenienti dalle ex-colonie) alla situazione del marito, nel caso in cui per esempio una donna stia entrando nel paese per ricongiunzione familiare o abbia ottenuto i documenti sposandosi; ecco perché il sistema di controllo migratorio opera con una logica contemporaneamente razzista e patriarcale”.
Fatiha racconta che “veniamo in contatto con un numero molto alto di casi di ‘irregolarità sopraggiunta’, come la chiamano loro, che sarebbe il caso ad esempio di donne che non possono rinnovare i documenti perché il loro marito non l’ha potuto fare. E ciò generalmente succede perché sono disoccupati. Abbiamo anche casi di famiglie che non possono rinnovare perché hanno cambiato casa e la loro abitazione attuale non soddisfa le misure che lo Stato esige per regolarizzarti. La legge stessa crea queste violenze e la struttura che le riproduce e qui entrano in gioco tutte le politiche di immigrazione”.
Nel caso delle donne marocchine, Fatiha raccoglie molte storie, con questioni e posizioni molto diverse, e ciascuna ha a che vedere con la ley de estranjería e con le sue conseguenze dirette o indirette. La logica sottostante a tutte queste situazioni è collegata a ciò che chiamiamo colonialità, ovvero con il mantenere i soggetti provenienti dalle ex-colonie al di sotto della linea dell’umano; si creano vite usa e getta come quella del ‘moro disoccupato’. Tutto ciò si ripercuote nella costruzione della donna ‘mora’ alla quale concediamo documenti solo in qualità di “moglie di” un uomo usa e getta. Il sistema relega la donna marocchina a un ruolo esclusivamente di cura, mentre la costruisce come sottomessa e inutile proprio per il fatto di svolgere quel ruolo. L’apparato ideologico che mantiene quest’ordine perverso è stato e continua a essere analizzato anche nel nostro contesto, per chi lo voglia leggere/ascoltare.
Questa violenza razziale istituzionale fatta di effetti quotidiani, materiali, è prodotta in prima istanza dai/dalle lavoratrici delle istituzioni deputate a controllare, soccorrere, aiutare, integrare le donne razzializzate/migranti. L’intervento sociale è uno strumento dello stato razzista per controllare le popolazioni non bianche.
“Un femminismo per tutte le donne” e la questione del razzismo
“Non siamo noi a dividere i movimenti, è che i movimenti stessi sono nati divisi e frazionati per le nostre realtà e necessità. Questo ha ritardato soluzioni più radicali alla nostra problematica perché abbiamo perso molto tempo delegittimandoci l’un l’alto e facendo a gara per chi avesse la ragione storica”
Aura Cumes
La sinistra bianca inizia a parlare sempre più di razzismo, anche se fatica a comprendere gli effetti reali dell’esistenza delle razze sociali e la violenza strutturale del razzismo di stato nei confronti delle comunità razzializzate e immigrate. Con il femminismo bianco succede la stessa cosa. I femminismi bianchi perpetuano l’essenzializzazione della donna e depoliticizzano gli interessi specifici della liberazione delle donne razzializzate e immigrate.
La categoria di donna come genere è già di per sé un termine coloniale. Lo hanno fatto presente diverse pensatrici come Oyeronke Oyewumi, la quale ha mostrato che anche le femministe “hanno camminato su un sentiero imperiale, aperto dal colonialismo e dal razzismo. Invece di essere coscienti del proprio vantaggio razziale si comportano come se la questione riguardasse l’evoluzione della propria cultura e per questo pretendono di civilizzare e salvare le donne africane”.
Chela Sandoval segnala che le donne razzializzate, a causa dell’oppressione di classe, genere, per la loro cultura, ma soprattutto per la razza, percepiscono che si possa loro negare l’accesso a una categoria di genere legittimata come quella della donna. Queste riflessioni contraddicono l’unità che le femministe bianche cercano erroneamente, così come la costruzione costante dell’omogeneizzazione; si focalizzano in un’oppressione come donne e dissidenti sessuali ma ignorano la differenza di razza, spesso coprendola con termini come sorellanza. Su questo ci avvertiva Audre Lorde mettendo in evidenza come “ignorare le differenze di razza tra donne e le implicazioni di queste differenze rappresenta la minaccia più grave alla mobilitazione comune”. Ci sarebbe da chiedersi se basti riconoscere le differenze per impegnarsi in una lotta decoloniale di donne.
Anche se negli ultimi anni abbiamo osservato un interesse nell’individuare le differenze – anche facendo un uso ‘sbiancato’ dell’intersezionalità – le richieste delle donne razzializzate si sono trasformate in un insieme senza importanza, in qualcosa di secondario. Inoltre lo pseudo riconoscimento delle differenze, il discorso dell’inclusione di donne razzializzate e migranti e la strumentalizzazione dell’intersezionalità hanno generato una specie di legittimità della sinistra bianca, mentre le nostre rivendicazioni sembrano essere una costante interferenza per il movimento ‘unificato’ delle donne bianche.
Le donne provenienti dall’immigrazione post-coloniale e le donne razzializzate nello stato spagnolo si trovano in una situazione molto specifica dinanzi alla violenza strutturale del sistema razzista e patriarcale. Non possiamo dimenticare ciò dice che Aura Cumer, pensatrice maya Kaqchikel: “fu sempre la colonizzazione ad avvicinare le donne bianche agli uomini per mezzo di un patto razziale, perché sebbene li divide la differenza di genere, li unisce il privilegio di razza”. In questo contesto mettiamo perciò in discussione l’alleanza ‘naturalizzata’ con le donne bianche, mentre vogliamo imparare dai femminismi neri e terzomondisti, che si allearono per i propri posizionamenti politici affini in merito all’oppressione di razza e che hanno costruito la propria coalizione attraverso impegni continui.
La disparità coloniale e l’oppressione razziale insinuano che la nostra liberazione causerebbe anche la perdita di potere delle donne bianche. Invece sono loro che devono rompere quel patto tacito con un sistema coloniale e uno Stato razzista, dominato dagli interessi capitalisti e imperialisti di cui hanno storicamente beneficiato e farla finita con queste logiche coloniali di lotta all’interno dello stato nazione. E unirsi invece a un reale progetto antisistemico, perché questo sistema perpetua la distruzione di ogni vita, di altre forme di sapere e di stare al mondo.
Nello stato spagnolo il femminismo bianco eurocentrico non ha smesso di agire. Il razzismo esercitato anche dalle femministe ha associato le donne razzializzate e immigrate a un patriarcato meno civilizzato, più volgare: conseguentemente siamo state inferiorizzate da un immaginario coloniale e civilizzatore. In questo contesto le donne razzializzate hanno esperienze comuni e sono capaci di sfidare e comprendere l’intero sistema strutturale oppressivo dello Stato in una dialettica con i propri fratelli e padri. La nostra voce è vitale, nel senso più letterale possibile.
Una prassi femminista decoloniale dall’Europa?
Arrivate a questo punto serve domandarsi: quale approccio abbiamo, qui e ora, noi donne migranti/razzializzate?
In generale ci troviamo a chiedere quote di rappresentazione all’interno del femminismo bianco e delle sue organizzazioni. Stiamo cioè colorando le narrative di liberazione moderna, legittimando la colonialità; o meglio, sperando che i movimenti di donne bianche con le loro narrazioni vogliano inserire nella loro agenda le nostre esperienze e richieste; riproducendo e legittimando l’assistenzialismo, assumendo e invisibilizzando il razzismo; aspettando che la femminista bianca di turno ci dia il permesso di portare l’hijab, di vivere le nostre vite, che trovi un modo di modellare le nostre esperienze di oppressione ai suoi schemi. Quando ci dicono che c’è posto per noi, chi stanno lasciando fuori o in cosa ci hanno trasformato? Stiamo forse cercando un riconoscimento individuale, elemosinando l’approvazione del/della bianco/a? Coinvolte in questa dinamica continuiamo ad alimentare la fascinazione per il/la bianco/a pretendendo di apparire astrattamente nei discorsi e nei progetti di emancipazione costruiti senza di noi e quindi contro di noi. Chiedere quote di rappresentazione si è già dimostrato inutile.
La domanda per noi è: per cosa lottiamo nel contesto spagnolo? Come ci organizziamo politicamente e strategicamente contro le oppressioni sistemiche che ci riguardano? Sicuramente non ci aspettiamo di trasformarci in qualche versione della donna bianca, né ancor meno dell’uomo bianco dominante. Il femminismo bianco esige che lo rendiamo compatibile con le nostre lotte antirazziste, di genere misto o non misto. Ciò che non possiamo permetterci a questo punto è imitare i metodi di liberazione femminista occidentalocentrici.
Rompere col processo di integrazione come pratica politica antirazzista comporta anche che mettiamo in discussione le forme di liberazione che abbiamo interiorizzato.
Un altro aspetto importante è trovare una strategia politica per lottare come donne razzializzate e migranti. Houria Bouteldja sottolinea l’importanza di comprendere bene contro quale egemonia lottiamo, e da dove origina la violenza. Non possiamo agire dalla stessa posizione di enunciazione delle donne bianche. Attraverso un’analisi più materialista e tenendo presente che sebbene le donne bianche sono vittime di violenza sono anche loro a livello strutturale quelle che opprimono il resto del mondo, comprese altre donne.
Nella lotta per un antirazzismo politico dobbiamo intendere il razzismo, il sessismo, le pratiche del capitalismo razziale e quelle imperialiste dello Stato come gerarchie collegate tra loro. D’altro canto se la sinistra bianca non lo capisce non potrà nemmeno comprendere come si costruiscono i discorsi delle donne razzializzate – né delle loro comunità o popoli colonizzati – dai quali nascono i loro movimenti. Se realmente lottiamo per una liberazione dobbiamo finirla con la fascinazione per l’occidente, che ancora ci lega a quelle narrazioni eurocentriche, e per il sistema fondato dall’uomo bianco attraverso la colonizzazione. Non è questo ciò che ci insegnano le nostre genealogie?
Ripensare l’eurocentrismo che struttura molti dei nostri spazi di lotta, così come rompere il silenzio, sono atti decoloniali. Dobbiamo abbandonare, se la nostra azione vuole essere davvero decoloniale, le pratiche che ci conducono solo a colorare la modernità, e che hanno come risultato soltanto la sua legittimazione e radicazione. Non dimentichiamoci che non siamo soltanto donne razzializzate.
Viviamo in una geografia europea e pertanto beneficiamo di questa civiltà di morte, liberale e imperialista, che si fonda e si rigenera sulla dominazione e sullo sfruttamento dei popoli del Sud – delle sue donne, dei suoi uomini, dei suoi bambini e bambine – e abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri popoli di origine.
La nostra critica è più complessa perché è la colonialità a ucciderci. Un progetto decoloniale in relazione alla lotta delle donne deve sviluppare un’altra politica e un’altra metodologia di liberazione. Dobbiamo riconoscere quando la nostra pratica politica si rende funzionale ai movimenti nati in seno alla modernità occidentale, quando si rende funzionale insomma alla colonialità.
La decolonialità non può essere un’ulteriore retorica che ci conceda una nicchia all’interno dei femminismi occidentalocentrici, un’identità che completi la ‘diversità’ di quel femminismo. Se ci sentiamo a nostro agio con quelle posizioni, tanto vale essere sincere con noi stesse e coi movimenti di uomini e donne del Sud che stanno costruendo alternative reali a questa civiltà di morte e smetterla di ‘sbiancare’ le loro lotte, i loro discorsi, le loro epistemologie.
Abbiamo grossi dubbi che il fine della decolonialità nata in quei territori serva a che noi, donne razzializzate che viviamo a Nord, possiamo inserirci meglio negli spazi bianchi.
Frasi come “io sciopero per quelle che non possono, per le migranti precarie senza documenti” per le nostre madri che non hanno letto i manifesti dello sciopero perché non sanno leggere e scrivere, per le nostre sorelle che non scioperano perché nessuna le ha invitate né le aspetta. Andare noi, dalle nostre posizioni di privilegio nei loro confronti, significa celebrare quel privilegio. Ancora di più quando, come sappiamo, lo sciopero è una strategia di lotta di uno spazio politico che non pensa da (né pensa a) le esperienze di quelle (nostre) donne. Noi che per la maggior parte non siamo più in quella situazione (anche se le nostre famiglie e amiche si) decidiamo di andare a quello sciopero per loro in un esercizio di universalizzazione delle strategie femministe bianche reinventate e relegittimate sui nostri corpi e nelle nostre pratiche, stavolta col nostro beneplacito. Smettiamo di celebrare la colonialità?
Fonte: https://www.elsaltodiario.com/1492/8m-perspectiva-decolonial