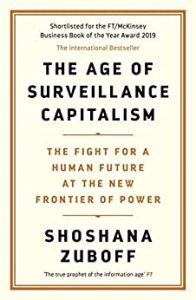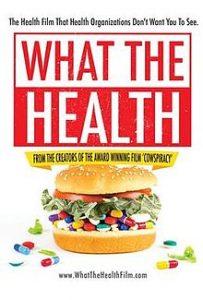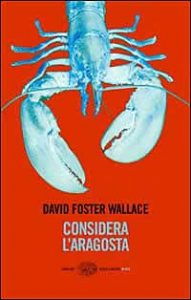Non è facile per me parlare di cosa abbia significato vedere ed ascoltare l’ultima performance di Hannah Gadsby, Nanette; dopo diversi giorni e tre visioni ancora sento risuonare dentro l’emozione.
Non mi ha mai attirato la stand-up comedy: non sopporto l’umorismo delle grandi voci privilegiate tutto giocato sulle discriminazioni e gli stereotipi e quando voci emarginate prendono parola spesso –troppo spesso- il modo più rapido ed efficace per essere ascoltate si basa su un umorismo autoironico, in una realizzazione della propria marginalità sul palco che mi suona da sempre davvero terribile.
Non è mai stato così per Hannah Gadsby, che ho sempre ammirato per il suo restare fuori da un facile umorismo e non può davvero essere così per la graffiante comedy Nanette.
Molt* comic* prima di lei hanno raccontato la loro esperienza di vita, ma Hannah fa molto di più: attinge a piene mani dalla sua stessa identità con l’obiettivo di incriminare la commedia stessa per la sua incapacità strutturale di fare di più per sostenere tutte le voci che sono costrette ai margini.
La performance di Hannah in Nanette è fondamentalmente un atto in tre parti di un discorso transfemminista profondamente radicale costruito tutto attorno alla sua esistenza fisica: ci porta al confronto con la realtà della sua identità fisica; poi afferma la propria umanità; infine sfida il pubblico a vivere il disagio che deriva da quella affermazione, senza concedere più il rilascio della tensione dato dalla battuta.
Hannah passa quindi i primi minuti di Nanette a far familiarizzare il pubblico con la sua identità, a rendere evidente ciò che significa esistere come donna queer, butch, non binaria, in un sistema sociale che ti ha sempre reso la battuta finale. Descrive come sia crescere come lesbica nella Tasmania conservatrice, isola famosa per le sue patate e per lo “spaventosamente limitato patrimonio genetico”, dove l’omosessualità era illegale fino al 1997. E fin qui piovono risate.
Poi, facendo riferimento al commento di un membro del pubblico che aveva obiettato non ci fossero abbastanza “contenuti lesbici” nel suo ultimo spettacolo, lei risponde: “Sono stata sul palco per tutto il tempo”.
Con questa battuta Hannah affianca perfettamente due idee che formano un paradosso: da un lato la centralità della sua identità all’interno della sua commedia, e dall’altro l’incapacità della commedia stessa di saper affrontare la complessità di tale identità.
Infatti dopo poco annuncia: “Dovrei smettere di fare comicità”. E da questo punto in poi Nanette diviene una folgorante rivelazione. “Ho fatto dell’autoironia il mio cavallo di battaglia. Ci ho costruito una carriera. Ma non voglio più farlo. Perché vi rendete conto di cosa può voler dire l’ironia per qualcuno che già di suo è marginalizzato? Non è umiltà. È umiliazione. Ironizzo su me stessa allo scopo di parlare, allo scopo di chiedere il permesso di parlare. E ho deciso che non lo farò più, né a me stessa né a chiunque si identifichi con me.”
E continua, scendendo ancora più in profondità nella disamina del suo lavoro: “Una battuta è fatta di due cose che lavorano insieme: un inizio e una battuta forte. Essenzialmente è una domanda con una risposta sorprendente. Ma in questo contesto una battuta non è altro che una domanda che io ho inseminato artificialmente. Tensione. È il mio lavoro. Suscito tensione in voi per poi farvi ridere e dire: “Grazie. Mi sentivo un po’ teso.” Sono stata io a farvi sentire tesi! È un rapporto pieno di abusi.”.
E questo è il cuore di tutto. Nanette è una performance sull’abuso: su come * comic* abusano del pubblico, su come gli uomini abusano delle donne, su come la società abusa della vulnerabilità delle persone che vivono ai margini.
Hannah dice che nel diventare una comica è stata complice del suo stesso abuso e di quello delle persone che si identificano con lei, poiché ha coperto la sua storia di traumi con le risate invece di scavare in profondità.
A questo punto la performance diventa sempre più cruda, le battute sempre più rare fino a tutta la potenza dell’ultimo atto di Nanette, in cui Hannah deliberatamente smette di essere divertente e diventa invece brutalmente onesta e coraggiosa conducendoci in un breve viaggio nella storia dell’arte e della malattia mentale di cui l’arte è inevitabilmente intrisa, una malattia mentale terribile, la misoginia.
E soprattutto in un viaggio nella sua vera storia personale, fatta di abusi e violenze. E inevitabilmente in questo momento, che è il più toccante e il più devastante del suo intero racconto, il pensiero vola velocemente al movimento #metoo e alla sua furia: quel movimento ci ha cambiate, ci sta cambiando; così come spero Nanette cambierà la commedia e tutt* * comic* non riescano mai più a dimenticare l’orrore che celano le loro battute.
S.P.