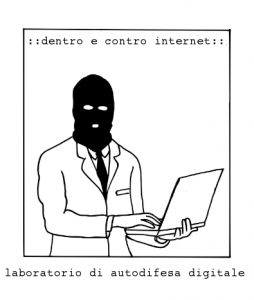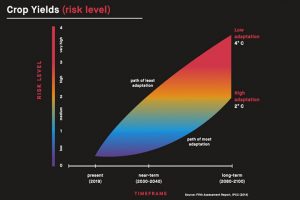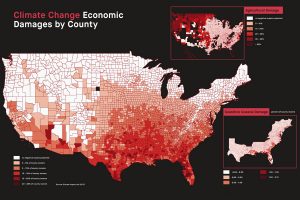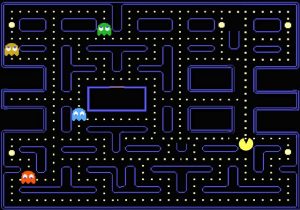Articolo tratto dal sito di Campagne in lotta: http://campagneinlotta.org/i-ghetti-le-lotte-autorganizzate-e-chi-se-ne-appropria-cronistoria-di-fatti-e-misfatti-dellusb/
Il 6 maggio 2019 circa 600 persone, residenti nella baraccopoli adiacente al CARA di Borgo Mezzanone (FG), insieme a decine di solidali hanno dato vita ad un corteo per dire no allo sgombero senza alternative che da mesi prosegue nel loro insediamento. Si tratta di uno sciopero dei braccianti, l’ultima di una lunga serie di mobilitazioni auto-organizzate che è iniziata nel settembre 2015. Da allora, sono sempre stati i braccianti africani (e più in generale chi vive nei ghetti) ad organizzare tutto, sono stati loro a portare le rivendicazioni davanti al prefetto, è con loro che le istituzioni e i rappresentanti degli agricoltori si sono dovuti confrontare.
Purtroppo però, come è già avvenuto in passato, questa mancanza di padrini politici non soltanto ha impedito alla loro lotta di trovare il sostegno che merita (a parte appunto i solidali che pur ci sono sempre stati). C’è anche chi ha cercato in tutti i modi di approfittare di questo ‘vuoto’, che in realtà è indice dell’unica possibile, reale forma di lotta, quella che vede protagonisti i diretti interessati. E così, come in passato, rendendosi conto dell’enorme potenziale che scaturisce dalla rabbia dei ghetti italiani, anche questa volta l’Unione Sindacale di Base (USB) ha indetto un corteo per il 6 giugno, usurpando le decisioni di un’assemblea autoconvocata in cui appunto si era deciso di fare un altro sciopero, prima che le ruspe tornassero a Borgo Mezzanone. Nessuno aveva chiesto l’intervento dell’USB, e in pochi erano d’accordo con la data del 6 giugno, ma questo all’USB e ai suoi dirigenti poco importa. Ciò che conta è incassare visibilità sulle spalle delle lotte faticosamente messe in piedi da altri.
Per noi che da anni seguiamo e sosteniamo le lotte autorganizzate di chi vive nei ghetti questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Siccome i fatti sono stati sistematicamente distorti nel rullo compressore della società dello spettacolo, sentiamo il bisogno di raccontare ancora una volta la nostra verità. Non si tratta di una guerra per il potere e la visibilità, ma semplicemente di pretendere che ciò che accade venga a galla, per evitare che le lotte vengano soffocate in uno squallido teatrino che le spoglia di tutta la loro potenza.
1. Tutto comincia in Basilicata: l’USB come meteora
Nel luglio 2015, a Venosa (PZ) apre uno ‘sportello migranti’ gestito da USB insieme alla Chiesa Evangelica Metodista. Nel corso del 2015 diverse compagne della rete Campagne in Lotta incontrano più volte Aboubakar Soumahoro, membro dell’esecutivo nazionale di USB e promotore dell’iniziativa a Venosa, per cercare un confronto. Aboubakar era un membro della mailing list che inizialmente faceva capo alla rete Campagne in Lotta, prima che, nel 2014, si verificasse una rottura riguardo all’accettabilità politica dei campi di lavoro progettati dalla Regione Puglia per la provincia di Foggia. Nonostante i tentativi di interlocuzione per arrivare a pratiche e lotte condivise, Soumahoro si dimostra sfuggente e il suo atteggiamento lascia intuire che non è intenzionato a collaborare.
Nell’aprile 2016, di concerto con la Regione Basilicata e il comune di Venosa, l’USB dice di voler attivare uno sportello anche a Boreano, un borgo abbandonato dove da anni sorge un insediamento informale di braccianti africani. Nel maggio dello stesso anno, un incendio distrugge parte dell’insediamento, già decimato da roghi precedenti. Sempre insieme alla Chiesa Metodista, dopo aver tenuto già un incontro in regione, l’USB organizza un corteo a Potenza che si conclude con un tavolo a cui partecipano la Regione stessa, il Comune di Venosa, la Questura e la Prefettura. Già in quella sede, i dirigenti USB (tra cui lo stesso Soumahoro) impediscono con uno stratagemma ad altri soggetti che negli anni si erano occupati della questione dei braccianti (Osservatorio Migranti Basilicata, Fuori dal Ghetto ed altri, con cui nell’estate del 2015 l’USB aveva fondato il coordinamento di associazioni) di partecipare al tavolo. Il 28 giugno, l’USB organizza un altro corteo, con relativo incontro, perché ritiene che gli accordi con la regione siano stati disattesi – è stato messo a disposizione un campo della Croce Rossa, ma non ci sono, a detta di USB, bagni e fornelli sufficienti, e sono vietate le visite. A fine luglio, le istituzioni procedono allo sgombero del ghetto di Boreano, a seguito della quale l’USB organizza un’altra protesta nel mese di agosto.
Dopo aver strappato al Comune di Venosa la promessa dell’iscrizione anagrafica per chi vive e lavora nelle campagne (ma solo a patto che viva nel centro di accoglienza), e dopo vari incontri senza nulla di fatto, una sedicente ‘assemblea nazionale dei lavoratori agricoli’ viene convocata proprio a Venosa. L’USB millanta la presenza di non meglio specificate delegazioni da tutta Italia. In quella sede, il verticismo ed il paternalismo del sindacato nei confronti dei braccianti migranti emergono chiaramente. L’ultimo atto dell’USB in questo territorio sarà l’ottenimento di una proroga di qualche mese della permanenza dei braccianti stagionali nel centro di accoglienza di Venosa, gestito dalla Croce Rossa, dove si erano verificati gravi abusi e carenze infrastrutturali (segnalate anche dall’USB). Dopodiché, Soumahoro e il suo sindacato scompaiono dalla scena, a parte un’unica assemblea ed un incontro al Comune di Palazzo San Gervasio nell’estate 2017, conclusosi con un nulla di fatto. In Basilicata ad oggi rimane aperto il solo campo di lavoro in stile carcerario di Palazzo San Gervasio, adiacente al CPR, nel silenzio generale. Nessun riferimento ovviamente alle donne che pur vivono nei ghetti, in Basilicata come in Puglia e in Calabria. Manco a dirlo, le promesse della Regione circa alloggio, trasporto e diritti contrattuali rimangono lettera morta, così come la possibilità per chi non ha un contratto di affitto di ottenere residenza fittizia.
2. Il silenzio di USB davanti alla protesta dei braccianti della provincia di Foggia e di Reggio Calabria
A partire da settembre 2015, in provincia di Foggia gli e le abitanti dei ghetti si organizzano e danno vita ad un importante ciclo di mobilitazioni, che include un blocco di 9 ore della più grande fabbrica di trasformazione del pomodoro in Europa. Era l’agosto 2016. Né l’USB né Aboubakar Soumahoro, che è anche una delle figure di punta della Coalizione Internazionale Sans Papiers e Migranti, mostreranno mai solidarietà con questa lotta auto-organizzata che ignorano sistematicamente nonostante ne siano palesemente a conoscenza, visti tutti i tentativi di interlocuzione portati avanti in quel periodo. Nell’ottobre 2016, dopo diversi cortei e presidi grazie ai quali sono state ottenute importanti vittorie riguardo l’iscrizione anagrafica e i permessi di soggiorno, gli e le abitanti dei ghetti della Puglia e della Calabria lanciano una mobilitazione nazionale contro confini e sfruttamento, che culminerà con un corteo auto-organizzato per le strade di Roma ed un incontro con il Capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Nonostante ripetuti inviti, Aboubakar Soumahoro non parteciperà né alle assemblee né al corteo, a cui aderiscono diverse realtà da tutta Italia, né si esprimerà in alcun modo a riguardo. Egli organizzerà però, proprio in quel periodo, un incontro ‘personale’ al Ministero dell’Interno, con gli stessi soggetti incontrati dalla delegazione del corteo autorganizzato.
3. …e il tentativo di usurpare e depotenziare il dissenso, in Puglia come in Calabria e in Piemonte
Pochi mesi più tardi, nel gennaio 2017, Aboubakar Soumahoro fa il suo primo ingresso nella Tendopoli di San Ferdinando (RC). Dimenticati i braccianti della lucania, si concentra su quelli di Puglia e Calabria, e poi della provincia di Cuneo, sempre con le stesse modalità.
i. La Calabria
Sin dal principio, nella Piana di Gioia Tauro l’USB si appoggia al Comune di San Ferdinando, che è responsabile della gestione delle tendopoli erette nell’Area Industriale a partire dal 2012 – gestione da sempre criticata dagli abitanti auto-organizzati, che attraverso le proteste hanno ottenuto piccole ma significative vittorie a partire dai primi mesi del 2013, sostenute dalla rete Campagne in Lotta e da altr* solidali. Mentre l’USB inizia le sue manovre, la mobilitazione auto-organizzata prosegue: il 6 febbraio e il 22 marzo gli abitanti della Tendopoli di San Ferdinando danno vita ad altri momenti di protesta, anche in coordinamento con altri territori. Ancora una volta, tristemente e prevedibilmente, USB tace e lavora per accaparrarsi il potenziale del dissenso, mentre Soumahoro si afferma progressivamente come protagonista indiscusso dei salotti televisivi italiani in quanto presunto portavoce dei ghetti. Come emergerà chiaramente nel corso dei mesi e degli anni successivi, la sua presenza e la sua azione risulteranno innocue quando non dannose alla causa di chi vive in condizioni di grave sfruttamento, violenza e segregazione.
È solo grazie alla determinazione degli abitanti della Tendopoli che si aprono tavoli di trattativa con Comune di San Ferdinando, Prefettura e Questura di Reggio Calabria. Ed è proprio in questo contesto favorevole che arriva l’USB. Prima intercettando le persone più abili a parlare offrendo loro soldi e in alcuni casi un alloggio altrove, come alcuni di loro raccontano. Successivamente, sostenuti dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni, i sindacalisti hanno iniziato a diffondere il ben noto teorema per cui fare le manifestazioni da soli è pericoloso poiché si rischia di perdere i documenti, i solidali sono dei criminali e quindi l’unica soluzione è farsi guidare da un sindacato. Da questo momento in poi inizierà un crudele gioco, per cui ai momenti di lotta autorganizzata degli abitanti della tendopoli seguiranno incursioni dell’USB volte a placare gli animi e spingere le persone dalla propria parte.
Ecco quello che è accaduto.
In seguito alla partecipatissima manifestazione del 6 febbraio, l’USB convoca un’assemblea domenica 26 febbraio nelle stanze del Comune di San Ferdinando. Scavalcando completamente la lotta autorganizzata degli abitanti della tendopoli, Aboubakar Soumahoro utilizza quello spazio per raccontare gli esiti del suo incontro “personale” avuto con il Ministero dell’Interno sulla condizione dei permessi di soggiorno delle persone che vivono nelle campagne. Saluta i presenti con la promessa di verificare insieme al sindaco di San Ferdinando la possibilità di soluzioni alternative a un ghetto. Sempre di domenica e nel Comune di San Ferdinando, il 19 marzo Soumahoro ripropone lo stesso format parlando di vaghe soluzioni abitative e permessi di soggiorno, e millantando di avere conquistato il rilascio della residenza per chi vive nelle tendopoli (quando questa in realtà era una conquista già assodata, ottenuta grazie alla tenacia degli abitanti e solidali). Viene dato ampio spazio al sindaco che promette case per tutti. Questa volta è sostenuto anche dai delegati della tendopoli che oltre a fare eco ai suoi discorsi hanno messo in piedi anche una rete di spie, pagate, pronte a riferire di ogni assemblea e incontro.
Tant’è che di lì a pochi giorni, il 22 marzo scendono di nuovo in strada per protestare contro i controlli, le identificazioni e le perquisizioni a tappeto eseguite nei giorni precedenti nella tendopoli e per le strade, e per continuare a chiedere documenti, case e contratti per tutti. Il giorno stesso ottengono un incontro con la Questura, presso il Commissariato di Gioia Tauro, per discutere nel dettaglio tutte le problematiche legate ai permessi di soggiorno. La lotta continua e il 13 aprile gli abitanti della tendopoli organizzano un altro corteo per i documenti, i contratti di lavoro e le case. Così come il 2 luglio, dopo che un grande incendio ha distrutto metà tendopoli, per fortuna senza vittime. Questa lotta rimane inascoltata dalle istituzioni e sedata dall’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dall’USB.
In questo clima si arriva all’annunciato sgombero della tendopoli, rispetto a cui l’alternativa proposta è un’altra tendopoli per chi è regolare con i documenti, dotata di sistemi di riconoscimento biometrici, con regole severe circa ingressi, uscite, e autonomia personale – insomma un carcere per lavoratori, le cui condizioni l’USB ha il coraggio di definire ‘appena decenti’. Anche in questa occasione i diretti interessati sono molto chiari e determinati: se l’alternativa alla tendopoli è una prigione, loro da lì non si muovono. Il 18 agosto, il giorno dello sgombero, la posizione dell’USB, così come della CGIL, di SOS Rosarno e di altre associazioni accorse per l’occasione è altrettanto chiara: persone (italiane) che non si sono mai fatte vedere alla tendopoli, se non per qualche rara passerella, trascorreranno diverse ore a convincere le persone, con le promesse e con il ricatto (si minacciavano infatti gli abitanti che avrebbero perso il domicilio legale e quindi il permesso di soggiorno), a trasferirsi nella nuova tendopoli. Alla fine qualcuno andrà e qualcun altro rifiuterà, ma nessuno se la passerà meglio di prima, anzi le manovre delle istituzioni e delle sue braccia operative, come l’USB, hanno contributo a creare un clima di paura e diffidenza reciproche, a dividere le persone e distruggere le lotte e i percorsi di autorganizzazione. Aggiungendo a tutto questo il fatto che a tre solidali sono stati comminati altrettanti fogli di via e una ventina sono sotto processo per aver partecipato alle mobilitazioni. Ancora una volta, nessuna solidarietà per questi compagni e compagne – anzi, ci sarà chi gioisce (a mezzo stampa) dei fogli di via, calunniando le compagne, come alcuni esponenti di LasciateCIEntrare ed SOS Rosarno.
Il 2018 invece purtroppo verrà ricordato anche come l’anno dei morti negli incendi nella tendopoli e non solo. La prima è Becky Moses, il 27 gennaio. In quell’occasione l’USB, dopo un silenzio di mesi, convoca una manifestazione in sua memoria. Gli abitanti del ghetto intanto provano a riorganizzarsi, ma molti hanno paura, e chi non si arrende è sottoposto a diverse forme di intimidazione e ricatto. Il 2 giugno è Soumaila Sacko ad essere ucciso, questa volta da una fucilata, perché scoperto a “rubare delle lamiere”. Questa volta l’intervento dell’USB e in particolare di Soumahoro è una vera e propria operazione di marketing. Prima di tutto vengono immediatamente sedati e impediti i tentativi di rivolta degli abitanti del ghetto. In un attimo Soumaila diventa ‘il sindacalista dell’USB ucciso dalla malavita’ (cosa che si rivelerà essere falsa, per stessa ammissione di alcuni dirigenti dell’USB durante un incontro tenutosi qualche mese dopo con alcune compagne della rete Campagne in Lotta, per cercare di comprendere meglio ciò che sta accadendo nella Piana di Gioia Tauro e non solo) e la sua faccia, come un’icona, compare dovunque. In nome suo e per la sua famiglia viene attivata una raccolta fondi, e l’USB incontra il Presidente della Camera invitandolo a visitare le Tendopoli di San Ferdinando, cosa che farà l’11 giugno, accompagnato nella sua passerella dalla stessa USB. In quell’occasione, l’USB esulta per le promesse e le dichiarazioni di Fico, che, manco a dirlo, rimarranno lettera morta. Il 4 luglio sarà la volta di Luigi Di Maio, incontrato a Roma da Soumahoro ed altri, che lo definiscono un ‘incontro proficuo’. Anche qui, niente più che parole e accordi ambigui.
Nel frattempo, Soumahoro diventa il paladino dei diritti dei lavoratori e della sinistra italiana, e a quel punto tra la frenesia dei social e la lontananza, non solo geografica, di luoghi come il ghetto è facile il creare il mito. Ma se ci si ferma un attimo la farsa è evidente: il sindacalista “porta avanti la lotta” tra selfie, talk show, tweet, foto, strette di mano – dei lavoratori neanche l’ombra, nonostante questi continuino a scendere in strada. Il macabro teatrino non si ferma nemmeno con la morte di Suruwa Jaiteh, avvenuta il 2 dicembre perché anche la sua tenda è andata in fiamme. Anche questa volta l’USB non perde l’occasione di utilizzare l’ennesima tragedia per ribadire la sua presenza.
L’anno nuovo, il 2019, non vede cessare i tentativi di organizzarsi tra gli abitanti della tendopoli. La loro vera voce esce fuori, ma i controlli e i controllori sono tanti. Allo stesso tempo l’USB sta iniziando a perdere terreno, i lavoratori prendono le distanze perché non vedono nessun risultato e si sentono presi in giro anche rispetto ai soldi raccolti in seguito alla morte di Soumaila, che sembrano essere spariti nel nulla. Soltanto dopo le pressioni degli abitanti delle tendopoli la famiglia di Soumaila riceverà una parte (piuttosto esigua rispetto al totale) del denaro raccolto con il crowdfunding. Il 16 febbraio le fiamme si portano via Moussa Ba e l’USB condanna pubblicamente il sistema dei campi. Peccato che neanche sei mesi prima cercava di convincere le persone che era meglio vivere in una tendopoli nuova che in una vecchia. E per meglio ripulirsi la faccia si unisce al Comitato per il riutilizzo delle case nella Piana di Gioia Tauro, altro contenitore vuoto che si muoverà tra comizi ed eventi, che vedranno la partecipazione di altri ‘VIP’ della sinistra italiana, senza mai ascoltare e coinvolgere i diretti interessati che nel frattempo reclamano le case costruite per loro a Rosarno, completate e mai assegnate, su cui tutti tacciono.
Poche settimane dopo, il 6 marzo, avverrà il pluriannuciato sgombero della vecchia tendopoli. Il dispiegamento di forze dell’ordine è senza precedenti per un’operazione del genere, 1000 uomini, uno per ogni abitante, elicotteri, ruspe e altro ancora. In questo epilogo del ghetto quel che resta dell’USB sono le lacrime di coccodrillo insieme alle associazioni, la CGIL e il Comune: “non doveva andare così, poveri ragazzi”. Nei giorni e settimane precedenti lo sgombero, l’USB insieme ad altre associazioni aiutano le forze dell’ordine nelle operazioni di schedatura degli abitanti della vecchia tendopoli, propedeutiche alla loro deportazione (con tanto di numeri affissi ai loro indumenti). Ad oggi chi vive nell’unica tendopoli rimasta è ancor di più isolato e controllato. Chi ci ha guadagnato da tutto questo?
ii. La Puglia
Già nell’inverno del 2016 la locale sezione dell’USB di Foggia e provincia aveva contattato alcune compagne della rete Campagne in Lotta, chiedendo un confronto ed una collaborazione alla luce della loro esperienza sul campo, e stante la scarsa preparazione dei sindacalisti per loro stessa ammissione. Pur con le riserve del caso, un primo confronto era avvenuto nel mese di dicembre, e successivamente le compagne avevano fatto una serie di proposte al sindacato, senza trovare particolari sponde. Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2017, durante le fasi finali dello sgombero del cosiddetto ‘Gran Ghetto’, a pochi chilometri da Foggia, un incendio uccide nelle loro baracche Mamadou Konate e Nouhou Doumbia. La mattina successiva, una protesta totalmente auto-organizzata porta diverse centinaia di persone dal ghetto fin davanti alla Prefettura del capoluogo. Da USB non una parola in solidarietà alla protesta. Pochi giorni dopo, però, i suoi dirigenti – tra cui ovviamente Soumahoro stesso – organizzano in quel che rimane del ghetto un’assemblea, e rilanciano una nuova data di mobilitazione per l’8 marzo, all’ombra delle bandiere dell’USB. Appresa la notizia, alcuni compagni della rete Campagne in Lotta tentano di persuadere i dirigenti locali del sindacato a non gettare all’aria un anno e mezzo di mobilitazioni e conquiste strappate da chi si è auto-organizzato, e a continuare su questa strada in maniera compatta. I dirigenti locali si mostrano favorevoli all’impostazione e alla proposta, e incoraggiati da questa apertura alcuni compagni e compagne (abitanti dei ghetti e solidali) partecipano al corteo dell’USB, dove però i dirigenti nazionali (Soumahoro e Guidarello) procedono ad ignorarli sistematicamente, escludendoli dal tavolo in prefettura nonostante gli accordi stretti in precedenza. Questo comportamento porterà il neo eletto responsabile agricoltura dell’USB Foggia alle dimissioni. Il corteo, peraltro, sfrutta la visibilità della mobilitazione internazionale delle donne esibendo in prima fila la compagine femminile del ghetto, di cui non si è mai curato né si curerà mai in futuro.
Da quel momento, in quel che rimane del Gran Ghetto comincia a circolare la voce secondo cui lo sgombero è responsabilità delle compagne e dei compagni della rete Campagne in Lotta, a cui verrà in questo modo negata l’agibilità in quello spazio, in cui erano presenti dall’estate del 2012 e dove avevano faticosamente costruito rapporti di fiducia e collaborazione, che vengono spazzati via dalle calunnie di alcuni, che sfruttano il comportamento di USB per togliere di mezzo persone a loro scomode e continuare a mantenere l’egemonia sul ghetto. Intanto, USB inizia un’aggressiva campagna di tesseramento nel ghetto stesso, ignorando chi dal ghetto è stato deportato verso i campi di lavoro di San Severo in cui persistono condizioni di precarietà estrema, anche relativamente all’ottenimento della residenza. Il 1 maggio, in contemporanea con Reggio Calabria, si terrà un corteo di braccianti anche a Foggia, ancora una volta guidato dall’USB e dalle sue bandiere. Ma le condizioni di vita degli abitanti dei ghetti rimangono drammatiche, e l’USB non sembra in grado di instaurare alcun tipo di trattativa efficace con le istituzioni, se non per rivendicazioni minime e decisamente al ribasso rispetto a quelle delle lotte auto-organizzate. Il 12 maggio l’USB partecipa ad un confronto con il sindaco di San Severo, comune su cui sorge il Gran Ghetto, senza che da questo scaturisca alcuna misura per sanare la condizione di chi vive in quel che resta della baraccopoli. Il 31 luglio, a seguito di un corteo tenutosi a Bari, l’USB strappa la concessione dell’acqua potabile da parte della Regione per chi ancora vive nel Gran Ghetto, la cui erogazione verrà interrotta già dal mese di settembre. Le contromisure di USB si fanno attendere fino ad ottobre inoltrato, quando viene annunciato che il caso verrà portato all’attenzione della FAO (sic!) e che verrà presentato un esposto contro il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Soltanto il 10 novembre USB organizza uno ‘sciopero’ dei braccianti del ghetto che si concluderà con l’occupazione simbolica della cattedrale di Foggia e con un appello al Papa. Il giorno successivo l’erogazione di acqua verrà nuovamente ripristinata, ma le condizioni di chi vive nel ghetto rimarranno sostanzialmente immutate. Nei mesi seguenti, l’USB invita europarlamentari, candidati alle elezioni politiche ed altre figure pubbliche a passerelle all’interno del ghetto, esponendo i suoi abitanti all’ennesima operazione di mediatizzazione sulla loro pelle.
Il 16 dicembre, Aboubakar Soumahoro e la Coalizione Internazionale Sans Papiers e Migranti organizzano a Roma un corteo ‘Fight/Right, Diritti Senza Confini’, a cui porta una delegazione da Foggia e dalla Piana di Gioia Tauro. Ancora una volta, il corteo non entra nel merito delle reali questioni legate ai documenti, nell’ottica di un miglioramento delle loro condizioni, ma si limita ad una serie di proclami.
L’8 marzo 2018, l’USB dichiara che le donne braccianti del ghetto aderiscono allo sciopero globale delle donne. Ancora una volta, la condizione femminile viene strumentalizzata e distorta: quelle che l’USB vuol far passare per braccianti sono donne impegnate soprattutto nel lavoro di cura, in molti casi incluso il lavoro sessuale, le cui specificità non vengono minimamente considerate. In che cosa consisterebbe il ‘femminismo’ dell’USB?
Il 12 aprile USB organizza un nuovo corteo a Foggia, con annesso incontro istituzionale. Ancora una volta, USB rivendica di aver ottenuto l’iscrizione anagrafica per chi vive nei ghetti, vittoria che in realtà risale alle lotte auto-organizzate del 2015-16. L’agosto 2018 è un mese tragico per i braccianti del foggiano: due incidenti stradali si portano via un totale di 16 lavoratori e ne feriscono molti altri, tutti residenti nei ghetti della provincia. Un corteo auto-organizzato attraversa le strade del capoluogo il 7 agosto, ignorato da compagn* e media a parte i soliti solidali. L’8 agosto, prima del corteo organizzato dalla CGIL per il tardo pomeriggio, l’USB indice una ‘marcia dei berretti rossi’. Con un atto che definire paternalista ed irrispettoso ci pare eufemistico, nei giorni precedenti ai braccianti erano stati regalati cappellini rossi sponsorizzati da una onlus (‘Rete Iside’) come misura per la loro sicurezza sul lavoro. La marcia vede la partecipazione di Michele Emiliano, quello stesso che USB aveva minacciato di denuncia perché aveva ripetutamente disatteso gli accordi presi in sede di incontro. Al Presidente della Regione Puglia viene lasciato ampio spazio di parola, che egli si prende volentieri compiendo un’operazione manipolatoria in piena regola. Il corteo, dichiara, è in continuità con quello della CGIL. Da USB nessuna presa di distanza. Ancora una volta le morti di chi vive sfruttato e segregato vengono strumentalizzate senza scrupolo alcuno.
Il 3 settembre, in occasione della visita di Luigi Di Maio a Foggia, un nuovo presidio auto-organizzato viene convocato sotto alla Prefettura, pesantemente osteggiato e contenuto dalle forze dell’ordine, mentre Aboubakar Soumahoro siede al tavolo insieme al Ministro e ne appoggia il discorso e le proposte, di cui peraltro rivendica la paternità. Com’è ovvio, nessun riferimento alla protesta, le cui urla nonostante tutto raggiungono il palazzo. Il 22 settembre, si tiene a Foggia ‘l’assemblea nazionale USB sul lavoro agricolo’, in cui viene presentata una ‘piattaforma dei diritti e un codice etico’. Nelle settimane precedenti, l’USB ha più volte rivendicato e sbandierato l’invito al ministro dell’Agricoltura Centinaio (Lega) e al Presidente della Regione Puglia Emiliano. Nonostante i fieri proclami, però, nessuno dei due si presenterà, mentre manterranno fede all’invito, tra gli altri, l’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Angela Robbe, e il giornalista Gad Lerner. Dopo questo inutile circo, sulla provincia di Foggia calerà il silenzio dell’USB, che si guarderà bene dal pronunciarsi sulle manovre di sgombero cui il governo dà inizio nell’insediamento di Borgo Mezzanone a partire dal mese di gennaio 2019. Fino a quando non si ripresenta un’altra ‘ghiotta’ occasione: la morte in un altro rogo dell’ennesimo bracciante, il 25 aprile. Anche in questa occasione, un triste video di Aboubakar Soumahoro capitalizza e incamera consensi social davanti alle macerie della baracca dove ha trovato la morte Samara Saho. È questo l’ultimo atto dell’USB prima dello scippo della lotta auto-organizzata degli e delle abitanti di Borgo Mezzanone lo scorso 6 giugno, in un contesto in cui la popolarità di USB al ghetto è andata progressivamente riducendosi, visti i risultati delle mobilitazioni e le promesse disattese circa i problemi individuali di documenti di cui USB, e Soumahoro in prima persona, avevano detto che si sarebbero fatti carico.
iii. Il Piemonte
Sempre nel corso del 2017 l’ambiguo operato dell’USB e di Abou Soumahoro nello specifico arriva anche nella provincia di Cuneo, altro importante luogo di raccolta della frutta. Anche qui da anni i lavoratori e le lavoratrici portano avanti, in totale autonomia e con il sostegno dei solidali, una lotta per migliorare le proprie condizioni di lavoro e abitative. Durante quella stagione di raccolta l’intervento dell’USB si limita ad una serie di proclami e comunicati che non trovano alcun tipo di riscontro nella vita delle persone che lì vivono e lavorano.
L’anno successivo, il 10 luglio del 2018, non avendo un posto dove dormire i braccianti decidono in totale autonomia di occupare un’ex fabbrica, sita in Via Lattanzi a Saluzzo, anche perché in molti non avevano trovato posto nel dormitorio allestito dal Comune per la stagione di raccolta (ex caserma Filippi in zona Foro Boario, gestita dalla Caritas). Puntuale come un predatore arriva l’USB con il suo sindacalista Abou Soumahoro per mettersi alla guida di un corteo, che si terrà il 21 luglio per le strade di Cuneo e che, anche in questo caso, si concluderà con un nulla di fatto: un incontro in Prefettura del quale non si è mai saputo nulla. Ad oggi, dopo questo episodio l’USB non ha proferito parola su quanto accade a Saluzzo.