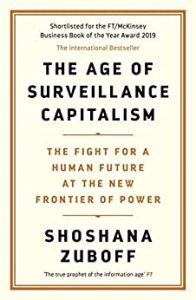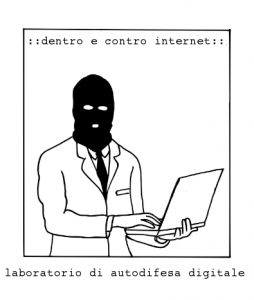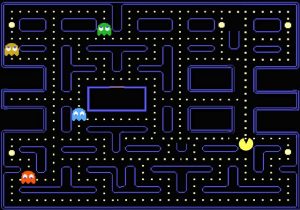Di Jocine Velasco
tradotto da https://communemag.com/the-uses-of-disaster/
Il cambiamento climatico è qui. Nel mezzo della tempesta, si presenta l’opportunità di rompere con il capitalismo e la sua spietata disuguaglianza. Cogliamo al volo l’occasione finché possiamo. Le alternative sono impensabili.
“Qual è questa sensazione che si manifesta durante così tanti disastri?” si chiede Rebecca Solnit nel suo libro del 2009 “A Paradise Built in Hell”. Esaminando le risposte umane a terremoti, incendi, esplosioni, attacchi terroristici e uragani nel corso dell’ultimo secolo, Solnit afferma che l’idea comune che i disastri rivelino il lato peggiore della natura umana è fuorviante. Invece, l’autrice dimostra come possiamo vedere in molti di questi eventi “una sensazione più profonda della felicità, ma intensamente positiva”, una speranza propositiva che galvanizza quelle che lei chiama “comunità della catastrofe”. Quando l’ordine sociale prestabilito viene temporaneamente sospeso, una miriade di “comunità d’eccezione” costituite attraverso la collettività e l’aiuto reciproco, nascono in risposta. Gli esempi di Solnit includono l’uragano Katrina, l’11 settembre e il terremoto di Città del Messico del 1985. Per momenti fugaci, dimentichiamo le differenze sociali e ci aiutiamo a vicenda. Ahimè, quando il disastro è passato, queste comunità svaniscono. Con le parole di A.Paradise, il “grande compito contemporaneo” che affrontiamo è la prevenzione di tale smottamento, “il recupero di questa comunanza di intenti senza crisi o pressioni”. Data la calamità del riscaldamento globale, questo compito diventa sempre più urgente. Come smantellare gli ordini sociali che rendono così catastrofici i disastri, mentre allo stesso tempo rendono ordinario lo straordinario comportamento umano che provocano?
L’argomentazione di Solnit suona vera anche se si è meno ottimisti di lei sul valore intrinseco della comunità. Negli inferni del presente, troviamo gli strumenti di cui abbiamo bisogno per costruire altri mondi, nonché scorci allettanti di qualcosa che spesso si ritiene impossibile. Questo non è motivo di giubilo, né di ottimismo. Ma è motivo di speranza.
Affinché questa speranza si realizzi, tuttavia, dobbiamo andare al di là dell’analisi empirica di Solnit su ciò che accade in risposta a specifici eventi disastrosi e cogliere il carattere generale della catastrofe capitalista. Questa non è semplicemente una serie di eventi singoli – gli uragani Katrina, Harvey e Irma – ma una condizione permanente. Per molti, l’ordinario è una catastrofe. Allo stesso modo, qualsiasi risposta coerente a tale catastrofe permanente dovrà essere diffusa e duratura per avere successo. Costruire il paradiso all’inferno non è abbastanza: dobbiamo lavorare contro l’inferno e andare oltre. Più che di comunità della catastrofe, abbiamo bisogno del comunismo della catastrofe.
Ovviamente, nel richiamare il comunismo della catastrofe, non stiamo suggerendo che il verificarsi di sempre più frequenti incubi eco-sociali in qualche modo inevitabilmente produrrà condizioni sempre più mature per il comunismo. Non possiamo adottare il fatalismo perverso del “tanto peggio, tanto meglio” né aspettare un ultimo uragano per spazzare via il vecchio ordine. Piuttosto, stiamo osservando che anche il più grande e terrificante di questi disastri straordinari può interrompere il disastro ordinario che è, per la maggior parte del tempo, troppo grande per essere compreso appieno. Ci sono momenti di interruzione che, sebbene siano terribili per la vita umana, potrebbero anche significare una catastrofe per il capitalismo.
Il comunismo della catastrofe non è separato dalle lotte esistenti. Piuttosto, enfatizza il processo rivoluzionario che sviluppa la nostra capacità collettiva di resistere e prosperare: un movimento all’interno, contro e al di là di questo disastro capitalista in corso. Come possono i numerosi progetti che creano mini-paradisi nell’inferno essere coerenti con qualcosa di più di comunità effimere? Il comunismo della catastrofe aggiunge una definizione chiarificatrice al longevo progetto politico che si contrappone allo Stato e al Capitale e trabocca i loro confini. Orienta il movimento di un potere collettivo che, pur essendo palpabile durante i disastri straordinari, resta sempre presente, specialmente nei luoghi e tra i gruppi che hanno vissuto la situazione di un disastro ordinario per centinaia di anni. Il cambiamento climatico fa diventare centrali le competenze esistenti in quelle lotte per la sopravvivenza.
IL CAPITALISMO DELLA CATASTROFE, IL CAPITALE COME CATASTROFE
Il geografo Neil Smith ha sostenuto in modo convincente che non esiste una catastrofe naturale. Denominare i disastri come “naturali” occlude il fatto che essi sono tanto il prodotto di divisioni politiche e sociali quanto di forze climatiche o geologiche. Se un terremoto distrugge le abitazioni a basso reddito mal costruite e mal mantenute in una città, ma lascia le case ben costruite dei ricchi, incolpare la natura significa semplicemente assolvere gli Stati, i costruttori e i padroni, per non parlare dell’economia capitalista che produce tali disuguaglianze in primo luogo. I disastri sono sempre co-produzioni in cui forze naturali come le placche tettoniche e i sistemi meteorologici lavorano insieme con le forze sociali, politiche ed economiche.
Il modo in cui si svolgono i disastri straordinari, quindi, non può essere separato dalle normali condizioni di catastrofe in cui si verificano. Era la categoria 4 dell’uragano Maria che ha devastato la colonia statunitense di Porto Rico, lasciando i residenti senza acqua potabile: un evento disastroso. Ma questa narrazione oscura il fatto che, prima dell’uragano, “il 99,5% della popolazione di Porto Rico era servita da sistemi idrici comunitari in violazione del Safe Drinking Water Act”, mentre “il 69,4% delle persone sull’isola era servito da fonti d’acqua che violavano gli standard sanitari di SDWA “, secondo un rapporto del Consiglio per la difesa delle risorse naturali. Né tali eventi devastanti possono eclissare disastri più lenti come quello di Flint, nel Michigan, dove decenni di abbandono e inquinamento industriale del fiume Flint e dei Grandi Laghi hanno lasciato la comunità operaia, la maggioranza nera e latina senza acqua pulita. Facilmente trascurati perché mancano del potere spettacolare di un uragano o di un terremoto, disastri così estesi sfociano il confine tra disastro come evento e disastro come condizione. Ciò che per alcuni è una scossa improvvisa e inaspettata è per gli altri una questione di realtà quotidiana intensificata.
I cambiamenti climatici aumentano significativamente la frequenza e la gravità dei disastri sia lenti che veloci. Il riscaldamento globale significa una maggiore quantità di energia che circola nell’atmosfera e nelle superfici oceaniche. Ad esempio, quando gli oceani caldi creano celle a bassa pressione, l’energia termica, sotto l’influenza della rotazione terrestre, viene convertita nell’energia cinetica caratteristica degli uragani roteanti e delle tempeste tropicali. Le temperature più calde danno origine a più energia, che deve essere espressa in qualche modo (l’energia non può essere distrutta: può solo cambiare forma). La fisica di questo processo è diabolicamente complessa e difficile da studiare, tuttavia è possibile fare delle previsioni. L’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite suggerisce che il cambiamento climatico distruggerà cibo e acqua, danneggerà case e infrastrutture e porterà siccità e inondazioni, ondate di calore e uragani, mareggiate e incendi. I progressi delle scienze dell’attribuzione e delle conoscenze raccolte dal singolo grado Celsius del riscaldamento globale già in atto hanno reso possibile quantificare il contributo del cambiamento climatico agli eventi meteorologici estremi. Ora possiamo collegare il riscaldamento globale a calamità come l’ondata di caldo europeo del 2003 e l’ondata di calore russa del 2010, che ha ucciso decine di migliaia di persone, senza contare innumerevoli tempeste, inondazioni e altri eventi meteorologici.
Il fatto che il cambiamento climatico sia esso stesso creato dall’uomo (o meglio, provocato dal capitalismo) sottolinea ulteriormente l’impossibilità di separare eventi disastrosi da condizioni disastrose. La relazione tra le due corre in entrambe le direzioni: le condizioni danno luogo a eventi che, a loro volta, comportano ulteriori condizioni di radicamento. L’obiettivo dello stato-nazione durante e immediatamente dopo i disastri straordinari è di solito imporre l’ordine piuttosto che aiutare i sopravvissuti, e per questo motivo gli eventi catastrofici generalmente esacerbano il sottostante disastro del capitalismo. Nel terremoto di San Francisco del 1906, fu inviato l’esercito. Tra 50 e 500 sopravvissuti furono uccisi, e gli sforzi di ricerca, soccorso e spegnimento degli incendi auto-organizzati furono interrotti. I tentativi dello stato di gestire il disastro si sono dimostrati una forza disordinata, che ha distrutto le forme di auto-organizzazione dal basso. Una simile attenzione repressiva ai “saccheggiatori” (ad esempio i sopravvissuti) ha segnato la risposta dello stato americano all’uragano Katrina a New Orleans. Il 4 settembre 2005, sul ponte di Danziger, sette agenti di polizia hanno aperto il fuoco su un gruppo di neri che tentava di fuggire dalla città allagata, uccidendone due e ferendone gravemente altri quattro. L’assassinio di sopravvissuti neri in cerca di sicurezza illustra i mezzi con cui lo stato cerca di precludere le possibilità emancipatorie che potrebbero apparire durante tali disastri. In tali situazioni, lo stato non cerca altro che un ritorno alla normalità catastrofica per i poveri, i migranti e i neri. Tali azioni sono contrarie alle raccomandazioni anche dei sociologi mainstream della catastrofe. Nel 1960, ad esempio, il sociologo-militare Charles Fritz ha sostenuto incisivamente come lo stereotipo di un diffuso individualismo antisociale e di aggressività fiorente durante i disastri non fosse radicato nella realtà. Ha anche notato con acutezza che la distinzione tra disastri e normalità può “trascurare convenientemente le molte fonti di stress, tensione, conflitto e insoddisfazione che sono incorporate [sic] nella natura della vita quotidiana”.
Le disastrose macchinazioni di Stato e Capitale non si fermano comunque a eventi localizzati e puntuali, ma vanno dal locale al globale. Come hanno dimostrato scrittori come Naomi Klein e Todd Miller, disastri straordinari sono usati per prolungare, rinnovare ed estendere i comuni disastri di austerità, privatizzazioni, militarizzazione, polizia e confini. Questo è il capitalismo della catastrofe: un circolo vizioso in cui le normali condizioni di disastro esacerbano eventi di disastro straordinari, a loro volta intensificandone le condizioni originali. Eventi disastrosi permettono allo stato di implementare ciò che Klein chiama la “dottrina degli shock”. Questo processo implica la riqualificazione delle infrastrutture distrutte, dell’energia e delle infrastrutture di distribuzione agli standard neoliberali; lasciare i poveri senza elettricità o acqua potabile, costringendoli a trasferirsi in luoghi ancora più vulnerabili ai cambiamenti climatici; e incarcerandoli quando resistono o cercano di attraversare i confini per sfuggire a questa situazione insostenibile. Nei mesi successivi all’uragano Maria, Porto Rico ha sperimentato ulteriori privatizzazioni, peggioramento delle condizioni di lavoro e l’arrivo di colonialisti verdi: presunti filantropi come Elon Musk che nascondono le loro imprese iper-capitaliste dietro il paravento del recupero ambientale. La storia di Flint è simile, con le offerte fatte da Musk di risolvere i problemi infrastrutturali.
Le forze che agiscono nell’interesse dello Stato e del Capitale si presentano in un certo numero di forme, ovviamente. Gli attivisti del “Common Ground Collective” che fornivano aiuti d’emergenza all’indomani dell’uragano Katrina sono stati intensamente molestati non solo dai poliziotti razzisti ma anche da gente bianca armata che ha colto l’occasione per recitare in uno scenario post-apocalittico da fine-dei-tempi, con l’approvazione tacita e talvolta attiva facilitazione, della polizia.
SOPRAVVISSUTI IN ATTESA DELLA RIVOLUZIONE
Quello che lo studio degli eventi disastrosi e delle condizioni disastrose ci insegna è che il cambiamento climatico non è semplicemente una conseguenza involontaria della produzione capitalista, ma una crisi di riproduzione sociale (un termine che si riferisce alle strutture sociali auto-perpetuate che consentono la sopravvivenza quotidiana e generazionale e nello stesso tempo servono a mantenere intatte le disuguaglianze). Riconoscere questo non ci dà solo una nuova prospettiva sul problema, ma indica anche una fonte di speranza. È importante ricordare che le vite dei poveri, dei diseredati e dei colonizzati non sono modellate dal solo disastro. Coinvolgono, ad ogni cambiamento, forme di sopravvivenza e persistenza, spesso sotto forma di conoscenze e abilità trasmesse di generazione in generazione. Come insiste il filosofo Potawatomi Kyle Powys Whyte, mentre le popolazioni indigene conoscono bene la catastrofe sotto forma di centinaia di anni di tentativi di dominio coloniale, in quelle centinaia di anni hanno sviluppato le capacità per resistere e sopravvivere a disastri ordinari e straordinari. La studiosa femminista marxista Silvia Federici, nel frattempo, ha mostrato come il capitalismo abbia a lungo cercato, senza successo, di sradicare violentemente tutte le forme di sopravvivenza non capitalista. Nel suo saggio del 2001 “Women, Globalization, and the International Women’s Movement”, sostiene che “se la distruzione dei nostri mezzi di sussistenza è indispensabile per la sopravvivenza dei rapporti capitalistici, questo deve essere il nostro terreno di lotta”.
Una lotta del genere avvenne all’indomani del terremoto di Città del Messico del 1985, quando i proprietari terrieri e gli speculatori immobiliari videro un’opportunità per sfrattare definitivamente le persone di cui volevano liberarsi da molto tempo. I loro tentativi di demolire abitazioni che offrivano bassi rendimenti da locazione e di sostituirle con costosissimi condomini sono un chiaro esempio di capitalismo della catastrofe al lavoro. Eppure gli abitanti della classe lavoratrice hanno combattuto con grande successo. Migliaia di inquilini hanno marciato sul Palazzo Nazionale, chiedendo al governo di prendere possesso delle case danneggiate dai loro proprietari terrieri per l’eventuale vendita ai loro inquilini. In risposta, sono state sequestrate circa 7.000 proprietà. Qui, quindi, vediamo che i disastri straordinari non creano semplicemente lo spazio allo Stato e il Capitale per consolidare il loro potere, ma anche per resistere a queste stesse forme: una “versione di sinistra della dottrina degli shock”, per adottare la frase di Graham Jones. Il disastro ordinario che è il capitalismo può infatti essere interrotto da questi incidenti che, sebbene orribili per la vita umana, rappresentano anche una momentanea rovina per il capitalismo. In un saggio del 1988 intitolato “The Uses of an Earthquake”, Harry Cleaver suggerisce che ciò è particolarmente probabile nel crollo della capacità amministrativa e delle autorità governative a seguito di disastri straordinari. Questo crollo è forse ancor più probabile in luoghi in cui la governance dipende dalla sorveglianza, dall’uso dei dati sensibili e dalle tecnologie dell’informazione.
Cleaver rileva inoltre l’importanza delle storie di organizzazione collettiva nei quartieri colpiti dal terremoto. I sopravvissuti avevano legami organizzativi, una cultura di mutuo aiuto e aspettative di solidarietà. Gli inquilini sapevano di avere le spalle coperte a vicenda a causa delle loro relazioni reciproche. Questo punto è cruciale, perché ci consente di comprendere la comunità della catastrofe, non semplicemente come una risposta spontanea a disastri straordinari, ma piuttosto come il venire alla ribalta delle lotte quotidiane per la sopravvivenza e le pratiche sotterranee di aiuto reciproco. La loro esperienza di organizzazione contro i comuni disastri del capitalismo ha lasciato i residenti ben equipaggiati per affrontare un disastro straordinario.
In effetti, le relazioni di sostegno preesistenti sono state più efficaci nel sostenere le comunità colpite dall’uragano Maria. Il “Centros de Apoyo Mutuo” è una rete di mutuo soccorso decentrata costituita da gruppi, centri e pratiche consolidati, che ha distribuito cibo, ripulito i detriti e ricostruito le infrastrutture dell’isola. Lo ha fatto più velocemente e con maggiore attenzione ai bisogni dei residenti, rispetto alle reti di assistenza e logistica internazionale. Attraverso una sorta di bricolage o “arte del fare con ciò che è a portata di mano”, i centri di assistenza reciproca dimostrano che i non specialisti possono rapidamente raccogliere e condividere strumenti e abilità per la sopravvivenza. In tal modo, creano anche nuove forme di solidarietà e vita collettiva che vanno oltre la sopravvivenza.
“Quelle tempeste sono passate, e hanno distrutto molte cose”, dice Ricchi, un membro della rete statunitense Mutual Aid Disaster Relief. “Eliminando la rete energetica e riducendo l’accesso al cibo e all’acqua, hanno lasciato al buio l’isola di Borikén [il nome indigeno di Taíno per Porto Rico]. Ma in quell’oscurità si sono svegliati innumerevoli Boricuas, restano svegli fino a tardi e si alzano presto, facendo il lavoro di riprodurre la vita”.
Quella vita non è solo banale: i gruppi organizzano feste, lezioni di ballo e sessioni di cucina collettiva, in modo che gli orizzonti comuni possano aprirsi oltre la disperazione.
In un senso convenzionale e strettamente economico, c’è scarsità in queste situazioni, sebbene la scarsità sia messa in discussione da un’abbondanza di legami sociali. Tuttavia, disastri straordinari possono anche spingerci a riconoscere che la scarsità è una relazione sociale piuttosto che un semplice fatto numerico: il modo in cui i beni e le risorse sono distribuiti determina chi può usarli. All’indomani dell’uragano Sandy, è stata superata una “scarsità” di strumenti, non attraverso la produzione o l’acquisizione di altro, ma attraverso una nuova organizzazione. Le raccolte di strumenti sono state impostate come alternative alle relazioni sociali individualizzate e mercificate che dominano la società capitalista. Ci mostrano che non dovremmo essere troppo frettolosi per associare il cambiamento climatico a una maggiore scarsità.
LA CATASTROFE DELLE MIGRAZIONI
Le comunità sono spesso definite dal loro contenimento all’interno di un determinato luogo geografico, e quelle citate sopra certamente si adattano a questo disegno: rispondono a disastri straordinari nei luoghi dove sono avvenuti quei disastri. Eppure il cambiamento climatico, naturalmente, costringe le persone a spostarsi da un luogo all’altro, così che l’organizzazione contro i suoi effetti disastrosi richiede anche più ampie comunità di solidarietà. Il numero di persone attualmente classificate come “migranti forzati” si trova attualmente, secondo le cifre dell’ONU, a 68,5 milioni. L’accelerazione di questa ondata di spostamenti è impossibile da ignorare. Entro il 2050 si prevede che ci saranno 200 milioni di persone che saranno “migranti climatici”: costrette a spostarsi a causa dei disastri, sia ordinari che straordinari, che il riscaldamento globale sta portando. Questo, per sottolineare bene il punto, riguarda una persona su cinquanta nel mondo.
Attualmente, molte persone sono sfollate internamente, con solo una piccola parte che viaggia verso l’Europa, il Nord America o l’Australia. Tuttavia, man mano che il clima si destabilizza e le condizioni peggiorano, molti dei luoghi che attualmente servono come rifugi diventeranno inabitabili. Viaggiare in zone di latitudine più elevata e attraversare i confini delle nazioni più ricche che le occupano diventerà così sempre più essenziale per le persone. Vivere lì rende uno meno vulnerabile agli eventi disastrosi, non ultimo perché gli stati-nazione ricchi restano meglio equipaggiati – almeno finanziariamente – per mitigarli. La tendenza di questo movimento globale verso nord probabilmente intensificherà gli sforzi per difendere queste zone: il “complesso militare-ambientale-industriale” sta già progettando nuove forme di violenza per difendere i confini. Gli sforzi comuni per combattere tale violenza costituiranno alcune delle più importanti lotte contro il disastro climatico.
Mentre scriviamo, diverse strutture per l’Immigrazione e le Forze Doganali negli Stati Uniti sono presidiate da un movimento di protesta che mira a interrompere le operazioni di rimpatrio e deportazione. Nel Regno Unito, gli attivisti hanno respinto con successo i tentativi del governo di estendere l’applicazione delle leggi restrittive sull’immigrazione anche nelle scuole. A Glasgow, negli anni ’90, un progetto solidale che univa i migranti con gli autoctoni ha avuto un tale successo che le comunità della classe lavoratrice si sono rivelate in grado di ostacolare i raid dell’alba che miravano a deportare i loro nuovi amici e vicini. A nostro parere, anche queste sono “comunità della catastrofe” e non sono meno importanti di quelle di Città del Messico post-85 e della New Orleans post-Katrina. Queste comunità della catastrofe, quindi, sono spiragli di speranza: i microcosmi di un mondo formato diversamente. La riproduzione sociale organizzata non attraverso il lavoro salariato, le merci, la proprietà privata e tutte le loro violenze associate, ma attraverso la cura, la solidarietà e la passione per la libertà. Dimostrano con la loro esistenza che l’esistente non è immodificabile.
PARADISO CONTRO INFERNO
Questa speranza è vitale, ma troppo spesso la speranza ci uccide. Abbiamo bisogno di qualcosa di più dei microcosmi, anche perché tali esperimenti possono essere preziosi anche per il capitale. Qui è importante notare che il capitale non è omogeneo: ciò che è buono per alcuni capitalisti è negativo per altri, e ciò che è male per i singoli capitalisti in un breve periodo di tempo può essere buono per il capitale nel lungo periodo. Quindi, mentre le comunità che nascono dai disastri potrebbero essere una cattiva notizia per alcuni capitalisti e attori statali, altri invece le guarderanno con interesse. Come ricorda Ashley Dawson, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha elogiato gli sforzi di soccorso influenzati dagli anarchici di Occupy Sandy dopo che l’uragano del 2012 ha travolto New York. Facendo così bene ciò che le forze statali e di mercato non potevano fare, i progetti di Occupy hanno mantenuto la vita sociale, dando a queste forze qualcosa da riconquistare una volta ripristinato lo status quo ante. E lo hanno fatto senza alcun costo diretto per lo stato.
Tale resoconto è parziale, ovviamente, e non considera il valore pedagogico delle comunità che nascono dai disastri. Al suo massimo, questo valore è allo stesso tempo negativo e positivo: il clamoroso “sì” a quegli altri modi di vivere urla contemporaneamente un “no” al comune disastro del capitale. La riproduzione sociale promossa è un cambio di direzione: un tentativo di riprodursi in altro modo e di resistere al ritorno del mercato che distruggerebbe i nostri corpi e il nostro ecosistema.
Lo vediamo chiaramente in molte delle “comunità della catastrofe” che nascono in risposta ai confini. Come Harsha Walia dimostra così brillantemente nel suo “Imperialismo di frontiera”, queste comunità non aiutano semplicemente le persone a mitigare la violenza del confine, ma resistono al concetto stesso di confine, come riassume bene lo slogan “No Borders”. In effetti, questa stessa frase evoca simultaneamente l’affermazione e la negazione su cui insistiamo: contrastare un aspetto di questo mondo mentre descrive le caratteristiche del prossimo. Questa è un’operazione politica dentro e contro l’inferno.
Tale negazione dovrà indubbiamente andare oltre la mitezza associata alle nozioni dominanti di comunità. Di fronte a quei poliziotti e vigilanti razzisti all’indomani dell’uragano Katrina, il Common Ground Collective si è impegnato in un’autodifesa armata ispirata alle Black Panthers e ad altri gruppi radicali. Né i conflitti esisteranno solo esternamente: il CGC ha anche dovuto trattare con i sostenitori che sembravano più interessati al “turismo della catastrofe” che ai loro sforzi di soccorso. Le comunità che nascono dalle catastrofi non saranno esenti dal gorgo della violenza che costituisce la catastrofe quotidiana: misoginia, supremazia bianca, classismo, abilismo, razzismo e numerose forme intersezionali di oppressione, sfortunatamente, si riverseranno nella loro organizzazione. Le comunità della catastrofe dovranno imparare come risolvere le cose altrimenti, mobilitando gli strumenti sociali e i processi di responsabilità che molti attivisti stanno già sviluppando oggi.
IL PARADISO OLTRE L’INFERNO
Il capitalismo è a proprio agio con il concetto di comunità. Troppo spesso, il termine è usato per etichettare la resilienza che il capitalismo stesso ha bisogno per sopravvivere al disastro ordinario e straordinario. Le comunità organizzate sono così svuotate da ogni potere trasformativo.
Non possiamo però abbandonare del tutto il concetto di comunità: una simile proposta sarebbe inutilmente idealistica, dato l’uso diffuso del termine. Ma riferirsi a comunità della catastrofe come quelle discusse sopra semplicemente come “comunità” significa negare il loro potenziale, legandole ad un presente in cui sono pur sempre ammirevoli e degne di attenzione, ma mai trasformative.
È per questo che insistiamo sul concetto di comunismo.
Laddove il comunismo è spesso presupposto dall’abbondanza materiale creata dalla produzione capitalista, il comunismo della catastrofe è radicato nell’abbondanza collettiva presente nelle comunità della catastrofe. Significa impossessarsi dei mezzi di riproduzione sociale. Non possiamo aspettarci, naturalmente, che ogni risultato sarà immediatamente comunista (la proprietà privata non è stata abolita in quelle comunità a Città del Messico nel 1985, per esempio). Il nostro uso del termine indica la vasta ambizione e il funzionamento di un movimento al di là di specifiche manifestazioni e risultati, la sua diffusione attraverso lo spazio e la sua esistenza continua al di là di disastri straordinari. Denomina l’ambizione di fondare niente meno che il mondo intero nell’abbondanza trovata nella riproduzione sociale della comunità disastrata. Come tale, soddisfa la definizione di comunismo che Marx ci dà: “il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti”.
Il comunismo del comunismo della catastrofe, quindi, è una mobilitazione sovversiva e trasformativa senza la quale la catastrofe in corso del riscaldamento globale non può e non deve essere fermata. Allo stesso tempo è la rovina delle molteplici ingiustizie strutturali che perpetuano e traggono forza dalla catastrofe, e una promulgazione della diffusa capacità collettiva di resistere e prosperare su un pianeta che cambia rapidamente. È estremamente ambizioso e richiede una ridistribuzione delle risorse su più scale; riparazioni per il colonialismo e la schiavitù; espropriazione della proprietà privata per le popolazioni indigene; e l’abolizione dei combustibili fossili, tra gli altri progetti monumentali. Siamo, chiaramente, ben lontani da ciò. Ma come notava Ernst Bloch, quello che è il “non-ancora” è già vivo nel nostro presente. Nelle risposte collettive al disastro, troviamo che molti degli strumenti per costruire quel nuovo mondo esistono già. Quando Solnit parla di quell’emozione “più profonda della felicità” che anima le persone sulla scia del disastro, coglie “uno sguardo su chi altro potremmo essere noi stessi e su cosa potrebbe diventare la nostra società”. Tra le rovine, nella terribile apertura dell’interruzione, lanciata contro le condizioni che producono e cercano di capitalizzare su quell’interruzione, siamo vicini al completo cambiamento, alla generalizzazione della consapevolezza che tutto – e tutti – potrebbero ancora essere trasformati. In altre parole, nella risposta collettiva al disastro, intravediamo un movimento reale che potrebbe ancora abolire lo stato di cose presenti.